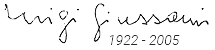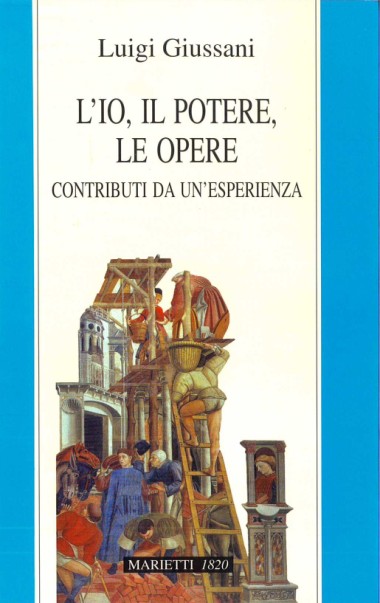Come si legge nella Nota introduttiva (p. 6), il volume raccoglie interventi, che l’Autore ha svolto in contesti talora molto diversi tra loro, sui temi della politica con particolare attenzione alla questione del potere, del lavoro e della creatività sociale. I testi, in parte inediti, in parte già pubblicati su periodici, sono suddivisi in quattro sezioni e un’appendice e riguardano un periodo di quasi trent’anni, dal 1970 al 1999.
Prima sezione: “Il potere” (pp. 7-48).
“Passione per l’uomo” (pp. 9-25) è la trascrizione inedita dell’incontro intitolato “Cristo e il potere” tenutosi a Padova presso la Basilica del Santo il 18 maggio 1987.
Nel 2000 il testo è proposto anche nel volumetto dal titolo L’io, il potere, le opere: Contributi da un’esperienza. The ‘I’, Power, Works: Contributions from an Experience. El yo, el poder, las obras: Contribuciones de una experiencia (Edizioni Nuovo Mondo, 2000, pp. 10-21), edito in occasione del Giubileo dei Governanti e dei Parlamentari (Roma, 4-5 novembre 2000).
“Un imprevisto è la sola speranza” (pp. 26-38) riporta gli appunti da una conversazione con Giussani sul tema del “senso religioso” (dato reperito presso l’Archivio della Fraternità di Comunione e Liberazione), svoltasi a Pescara il 10 gennaio 1987 presso il Centro Culturale Don Minzoni.
Nell’aprile di quell’anno, una prima versione del testo, identica a quella contenuta nel presente volume, è pubblicata con il titolo “I valori, il potere, l’imprevisto” in 30 Giorni (4, 1987: pp. 64-67).
Nel 1993, dopo una lieve revisione, lo scritto diviene parte della miscellanea Un avvenimento di vita cioè una storia: Itinerario di quindici anni concepiti e vissuti: Interviste, conversazioni, interventi di monsignor Luigi Giussani a partire da registrazioni, non rivisti dall’autore (a cura di Carmine Di Martino. EDIT: Il Sabato, 1993, pp. 415-427).
“Tra Barabba e lo schiavo frigio” (pp. 39-43) è l’esito di una conversazione fra l’Autore e alcuni universitari (Equipe del CLU) svoltasi a Rimini dal 31 gennaio al 2 febbraio 1987.
Lo scritto contenuto nel presente volume è identico alla prima stesura pubblicata nel maggio 1987 in CL-Litterae Communionis con il titolo “La persona contro il potere” (5, 1987: pp. 14-17. Con successive traduzioni).
In seguito il testo è stato riproposto diverse volte con redazioni differenti:
- nel luglio 1987, sul settimanale Il Sabato con il titolo “Come parlare di Cristo ai giovani” (luglio 25, 1987, pp. 19-20; molto rimaneggiato rispetto all’originale edito in CL-Litterae Communionis, 5, 1987);
- nel 1988, nella forma in cui uscì in Il Sabato, è ripubblicato nel volumetto Si ricomincia da Uno: Appunti da conversazioni di mons. L. Giussani con gli universitari di Comunione e Liberazione con il titolo “La persona rinasce in un incontro” (supplemento a Il Sabato, dicembre [24], 1988, pp. 67-81. Appunti non rivisti dall’Autore. Con successive traduzioni);
- nel 1993, dopo ulteriore revisione, è editato con il titolo “La persona rinasce in un incontro” in Un avvenimento di vita cioè una storia (EDIT: Il Sabato, 1993, pp. 209-217) e infine, nel 1997, è riproposto identico in 30 Giorni (3, 1997: pp. 39-46. Con successive traduzioni).
Nell’aprile 2010, l’intervento integrale di Giussani è pubblicato, assieme alla trascrizione dell’“Assemblea” e dell’“Omelia”, nel quinto volume della serie “L’Equipe” L’io rinasce in un incontro: (1986-1987), edito da BUR, con il titolo “Chernobyl” (“Sintesi”, pp. 181-196). Si tratta di una nuova versione redatta sulla base della documentazione scritta e audiovisiva conservata dall’Archivio della Fraternità di Comunione e Liberazione, per la quale è stata mantenuta la forma orale dei discorsi (BUR, 2010, p. 6).
“Più società meno stato” (pp. 44-48) è una relazione tenuta dall’Autore al Convegno nazionale promosso dall’Associazione Italiana Centri Culturali e dall’istituto ISTRA (Istituto di studi per la transizione) sul tema “Libertà e Potere: La Questione della Democrazia” (Milano, 21 maggio 1988, non 1987 come erroneamente riportato nelle “Fonti” del presente volume, p. 277).
Si tratta del testo edito per la prima volta a luglio 1988 in Synesis con il titolo “Libertà e potere” (1, 1988: pp. 9-12), poi riproposto identico nel numero di marzo/aprile 1989, in occasione della pubblicazione degli Atti del convegno (Synesis, 4 1988: pp. 7-10).
Sempre a luglio 1988, l’intervento di Giussani esce in CL-Litterae Communionis con il titolo “Passione per l’umano, ecco la molla di una democrazia viva” (7/8, 1988: pp. 10-11. Con successive traduzioni); in questa stessa forma si trova anche in CL-Rivista di Comunione e Liberazione in Svizzera con il titolo “Il gusto della differenza ecco la chiave della democrazia” (1, 1988: pp. 21-22), numero edito a dicembre.
Oltre a correzioni di carattere redazionale, si segnalano lievi discrepanze fra le diverse redazioni del testo, che modificano in parte il senso di alcune frasi. In particolare, la frase: «Ma resistere a questa surrettizia limitazione che permette e accetta nell’altro solo ciò che è ritenuto da me possibile ...» è riportata correttamente nella prima edizione (Synesis, 1, 1988: p. 11; 4 1988: p. 9; Marietti, 2000, p. 47), come si evince confrontando il testo con la documentazione audio conservata presso l’Archivio storico della Fraternità di Comunione e Liberazione; mentre in CL-Litterae Communionis (1988) è stato erroneamente aggiunto l’avverbio di negazione “non” («Ma non resistere a questa surrettizia limitazione ...», p. 11), che altera il senso della frase.
“«Sempre più in là»” (pp. 51-59) è il testo del discorso dell’Autore al raduno dei Giovani Lavoratori di CL dal titolo “Senso religioso e lavoro”, svoltosi a Bergamo l’1 maggio 1987, pubblicato nell’opuscolo Il lavoro dell’uomo: Interventi di monsignor Luigi Giussani (EDIT, 1988, pp. 9-16. Con successive traduzioni).
Nel 1987, CL-Litterae Communionis aveva proposto una sintesi dell’intervento, anch’essa intitolata “Senso religioso e lavoro” (6, 1987: p. 7. Con successive traduzioni), uscita senza la firma di Giussani.
Lo scritto “Amore a Cristo, radice del lavoro” (pp. 60-78) è un testo tratto da una conversazione dell’Autore con un gruppo di novizi dei Memores Domini (Milano, 15 novembre 1998).
Nel dicembre dello stesso anno, lo scritto è pubblicato con il titolo “Natale: motivo della vita come lavoro” in Litterae Communionis-Tracce (11, 1998: inserto. Con successive traduzioni).
Il capitolo “Dove Dio mi ha posto” (pp. 79-90) è costituito da due interventi che risalgono agli anni 1970 e 1971.
- Il primo paragrafo dal titolo “L’utilità della vita” (pp. 79-84) riporta quanto detto dall’Autore a un’assemblea di Giovani Lavoratori di CL, svoltasi a Viboldone il 15 novembre 1970 (non nel 1971, come erroneamente riportato nelle “Fonti”, Marietti, 2000, p. 278).
Il testo fu pubblicato per la prima volta nel 1971 con il titolo “Essere Chiesa sul luogo di lavoro: Il punto di partenza” in Litterae Communionis (9, 1971: pp. 11-14).
- Il secondo paragrafo, “Perché tu sia libero” (pp. 85-90), è l’intervento dell’Autore al Convegno nazionale di CL sul mondo del lavoro svoltosi a Parma il 6 giugno 1971. In quell’anno il contributo di Giussani fu pubblicato, insieme agli interventi degli altri relatori, all’interno dell’articolo “Stralci del convegno di Comunione e Liberazione sul mondo del lavoro” in Litterae Communionis (11/12, 1971: pp. 40-43).
“Dal cuore il lavoro, dal lavoro l’opera” (pp. 91-95) è l’intervento dell’Autore alla prima Assemblea nazionale della Compagnia delle Opere (Milano, 5 dicembre 1987), pubblicato nel 1988 con il titolo “Vivere con gioia la terra del Mistero” nell’opuscolo Il lavoro dell’uomo (EDIT, 1988, pp. 23-26. Con successive traduzioni), riproposto identico l’anno successivo in Le opere: “La fede senza le opere è morta” (Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, Milano 1989, pp. 18-19, “Grandi Quaderni di Litterae Communionis 4”) e nel 1991 in Corriere delle Opere (7, 1991: pp. 8-9).
Nel 1993, il testo, senza variazioni rispetto alle precedenti pubblicazioni, diviene il capitolo “Vivere con gioia la terra del Mistero” del volume miscellaneo L’avvenimento cristiano: Uomo Chiesa Mondo (BUR, 1993, pp. 87-91; nuova edizione: BUR, 2003).
Terza sezione: “Le opere” (pp. 97-161).
Il capitolo “La libertà alla radice dell’opera” (pp. 99-123) raccoglie tre interventi dell’Autore durante alcune assemblee nazionali della Compagnia delle Opere che ebbero luogo tra il 1992 e il 1995.
- “Le opere nascono solo quando uno ha il coraggio di dire «io»” (pp. 99-102), relativo all’assemblea del 14 marzo 1992 a Milano, è pubblicato per la prima volta in aprile, con lo stesso titolo, nell’opuscolo Intanto qualcuno costruisce: Atti dell’Assemblea nazionale: Milano 14 marzo 1992 (supplemento al Corriere delle Opere, 3 1992: pp. 5-8), poi riproposto a maggio in CL-Litterae Communionis (5, 1992: inserto. Con traduzione). L’anno successivo diventa parte della miscellanea L’avvenimento cristiano: Uomo Chiesa Mondo (BUR, 1993, pp. 111-115; ultima edizione: BUR, 2003, testo invariato, ma eliminata la suddivisione in paragrafi).
- “«Se l’uomo non costruisce come fa a vivere?»” (pp. 103-108), relativo all’assemblea del 12 febbraio 1994 svoltasi a Milano, è pubblicato nello stesso anno in Persona, famiglia, società: Atti dell’Assemblea nazionale della Compagnia delle Opere: Milano 12 febbraio 1994 con il titolo “La libertà che ci costituisce” (supplemento a Corriere delle Opere, 3, 1994: pp. 19-25. Con successiva traduzione).
- “Educazione alla libertà” (pp. 108-123), relativo all’assemblea del 25 marzo 1995 a Milano, è pubblicato integralmente, con lo stesso titolo, in Litterae Communionis-Tracce (6, 1995: inserto. Con successive traduzioni) e nell’opuscolo Educazione alla libertà: Compagnia delle Opere: Atti dell’Assemblea nazionale (supplemento a Corriere delle Opere, 6, 1995: pp. 13-24). Parte del testo è inoltre edita con il titolo “Educazione alla libertà” nella sezione “Insistenza” del volume Il rischio educativo: Come creazione di personalità e di storia (SEI, 1995, pp. 149-155). Rispetto all’edizione integrale dell’intervento, in SEI, 1995, sono stati espunti la parte introduttiva e i quattro punti conclusivi (cfr. Litterae Communionis-Tracce, 6, 1995: inserto, p. II e pp. IX-XII; L’io, il potere, le opere, Marietti, 2000, pp. 108-110 e pp. 118-123).
Il capitolo “Dacci un cuore grande per amare” (pp. 124-133) consta di due interventi:
- “Di fronte al bisogno” (pp. 124-129), testo dell’intervento al convegno “Nella carità la solidarietà diventa opera” (Tarcento, 25 ottobre 1986), organizzato in occasione del decennale del terremoto in Friuli.
Nel febbraio 1987 lo scritto è pubblicato per la prima volta con il titolo “La carità costruisce per sempre” in CL-Litterae Communionis (2, 1987: pp. 22-24. Con traduzioni); successivamente è rieditato senza variazioni nel libretto Il lavoro dell’uomo: Interventi di monsignor Luigi Giussani con il titolo “La carità si fa opera” (EDIT, 1988, pp. 17-21. Con successive traduzioni); nel 1993 diventa il capitolo “La carità costruisce per sempre” del volume miscellaneo L’avvenimento cristiano: Uomo Chiesa Mondo (BUR, 1993, pp. 81-86; nuova edizione BUR, 2003) e infine, successivamente alla riedizione nel presente volume, in occasione del Natale 2003 è pubblicato da ICOS, Impresa per la cooperazione e la sussidiarietà, in edizione privata, non destinata alla vendita, con il titolo La carità si fa opera.
- “Creare una casa più abitabile per l’uomo” (pp. 129-133), intervento dell’Autore all’Assemblea nazionale della CdO (Milano, 6 febbraio 1993), pubblicato con il titolo “Una passione per l’uomo” nel fascicolo Una tensione ideale: Assemblea nazionale Compagnia delle Opere: Milano 6 febbraio 1993 (supplemento a Corriere delle Opere, 4, 1993: pp. 7-10. Testo non rivisto dall’Autore) e, nello stesso anno, nel volume miscellaneo L’avvenimento cristiano: Uomo Chiesa Mondo (BUR, 1993, pp. 117-121; nuova edizione: BUR, 2003). Il testo non ha subito modifiche, fatta eccezione per il breve saluto finale di Giussani, presente solo nel fascicolo allegato al Corriere delle Opere (4, 1993: p. 10).
“Di fronte al bisogno, un’ipotesi positiva” (pp. 134-147) è l’intervento dell’Autore all’Assemblea nazionale della CdO (Milano, 25 maggio 1996), già pubblicato con il titolo “La fede dentro il bisogno dell’uomo: l’esperienza del divino” in Una storia che costruisce: Fatti e incontri: Atti dell’Assemblea nazionale della Compagnia delle Opere: Milano 25 maggio 1996 (supplemento a Corriere delle Opere, 6, 1996: pp. 7-14) e in Litterae Communionis-Tracce (7, 1996: inserto. Con successive traduzioni).
Il capitolo “La compagnia si dilata in libertà” è costituito da due testi:
- “Veramente utili alla compagnia umana” (pp. 148-154), intervento all’Assemblea nazionale della CdO svoltasi a Milano il 26 gennaio 1991.
Il testo sarà oggetto di numerose ripubblicazioni.
Nel 1991 è pubblicato con il titolo “La felicità e le opere” in Corriere delle Opere (3, 1991: pp. II-IV) e , con il titolo “Perché tu sia felice”, in CL-Litterae Communionis (3, 1991: inserto. Con successive traduzioni) in forma lievemente modificata; aggiunta di titoli ai paragrafi.
Con alcune modifiche, è editato con il titolo “Veramente utili alla compagnia umana” in Corriere delle Opere (7, 1991: pp. 13-15) e nel 1993, in forma identica, in L’avvenimento cristiano: Uomo Chiesa Mondo (BUR, 1993, pp. 103-110; nuova edizione: BUR, 2003). In questa forma si trova ora nel presente volume.
- “Le opere: realismo e creatività della fede” (pp. 154-161), intervento introduttivo all’Assemblea nazionale della CdO del 4 marzo 1989 (Milano), esce, nel 1989, in CL-Litterae Communionis (4, 1989: pp. 8-11. Con successive traduzioni) e successivamente, senza variazioni, nel fascicolo intitolato Le opere: “La fede senza le opere è morta” (Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, 1989, pp. 20-23, “Grandi Quaderni di Litterae Communionis 4”), in Corriere delle Opere (“Le opere. Realismo e creatività della fede”, 7, 1991: pp. 10-12) e, nel 1993, diventa il capitolo omonimo del volume miscellaneo L’avvenimento cristiano: Uomo Chiesa Mondo (BUR, 1993, pp. 93-101; nuova edizione: BUR, 2003).
Quarta sezione: “La politica” (pp. 163-182).
“Assago 1987. Senso religioso, opere, politica” (pp. 165-170), intervento di Giussani all’Assemblea della Democrazia Cristiana lombarda svoltasi ad Assago il 6 febbraio 1987.
Il testo è stato pubblicato numerose volte in forme differenti.
A) In febbraio esce una prima redazione in Il Sabato con il titolo “L’infinito e le opere” (febbraio 14, 1987, pp. 3-4); in questa forma, nel 1988 l’intervento di Giussani è riportato nell’opuscolo Cattolici e politica con il titolo “Potere e desiderio: L’esperienza dell’uomo interroga la politica” (Scuola di Dottrina sociale, 1988, pp. 10-11; espunte alcune righe iniziali).
B) Nel mese di marzo 1987 il testo, che ha subito una lieve revisione, è pubblicato in CL-Litterae Communionis, con il titolo “Il senso religioso, le opere, il potere” (3, 1987: pp. 7-8; aggiunta la suddivisione in paragrafi. Con successive traduzioni). Rispetto alla prima redazione (febbraio, 1987) è stato espunto l’ultimo capoverso della prima colonna (Il Sabato, febbraio 14, 1987, p. 4). In questa stessa forma e con lo stesso titolo, nel 1989 è riproposto in Le opere: “La fede senza le opere è morta” (Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, Milano, 1989, pp. 16-17, “Grandi Quaderni di Litterae Communionis 4”).
C) Sempre nel 1987, è proposto con alcune modifiche anche nel volumetto La politica per chi per che cosa: Più società meno Stato: Antologia per una dottrina sociale con il titolo “Il senso religioso, le opere, il potere” (supplemento a Il Sabato, maggio 30, 1987, pp. 7-12). Il testo comprende il capoverso a p. 11, espunto nella versione pubblicata in CL-Litterae Communionis (3, 1987).
Nel 1992, è riproposto identico in Il Sabato con il titolo “I ciellini e la politica” (settembre 19, 1992, pp. 90-93) e, nel 1993, nell’“Appendice alla prima sezione: Una nota sulla politica” della miscellanea Un avvenimento di vita cioè una storia: Itinerario di quindici anni concepiti e vissuti, con il titolo “Il senso religioso, le opere, il potere” (EDIT: Il Sabato, 1993, pp. 111-118).
In questa forma è pubblicato nel presente volume (Marietti, 2000), con l’aggiunta delle note a piè di pagina. Nel mese di ottobre, è riproposto nel volumetto L’io, il potere, le opere: Contributi da un’esperienza. The ‘I’, Power, Works: Contributions from an Experience. El yo, el poder, las obras: Contribuciones de una experiencia (Edizioni Nuovo Mondo, 2000, pp. 5-9), edito in occasione del Giubileo dei Governanti e dei Parlamentari (Roma, 4-5 novembre 2000).
Nel 2009, è rieditato dal quotidiano L’ordine con il titolo “Il senso religioso degli affari come lo vedeva don Giussani” (6 maggio 2009, pp. 1-2;) e, nel 2016, in appendice al libro di Aldo Brandirali Ricostruire: Scuola di politica, col titolo “Il senso religioso, le opere, il potere” (DeCo Democrazia e Comunità, 2016, pp. 188-194; le note sono riportate tra parentesi tonde nel testo).
D) Il 29 dicembre 1993 l’intervento, con una redazione ancora differente, esce su Avvenire con il titolo “Il primato della società di fronte allo stato” (29 dicembre 1993, p. 18). Come spiegato nella nota editoriale introduttiva, si tratta di un’anticipazione del testo che sarà pubblicato nel gennaio 1994 in Litterae Communionis-Tracce con il titolo “Punto di vista sulla politica” come contributo rispetto alla situazione politica del tempo (1, 1994: inserto. Con successive traduzioni). Rispetto alle versioni precedenti, oltre a correzioni di carattere redazionale, sono stati aggiunti i titoli ai paragrafi.
Lo scritto non fa invece parte del volume L’avvenimento cristiano: Uomo Chiesa Mondo (BUR, 1993), come erroneamente riportato nelle “Fonti” (Marietti, 2000, p. 279).
“Il desiderio e la politica” (pp. 171-178) è un testo tratto da una conversazione fra Giussani e alcuni esponenti politici cristiani (Centro Culturale San Carlo, Milano, 30 aprile 1987), già pubblicato con il titolo “Il desiderio e la politica: Appunti da una conversazione di mons. Luigi Giussani con alcuni esponenti politici cristiani al Centro Culturale San Carlo” nel volumetto La politica per chi per che cosa (supplemento a Il Sabato, maggio 30, 1987, pp. 22-30. Con successiva traduzione).
“Affermare l’altro in quanto è” (pp. 176-182) ripropone il paragrafo “Democrazia”, parte del capitolo “Missione” del volume Appunti di metodo cristiano (Gioventù Studentesca, 1964, pp. 91-96; diverse ripubblicazioni), in seguito divenuto parte del volume Il cammino al vero è un’esperienza (Rizzoli, 2006, pp. 189-193; prima edizione: SEI, 1995, pp. 120-123).
Appendice: “Articoli e interviste” (pp. 183-275).
Chiude il volume un’ampia appendice che raccoglie interviste all’Autore e articoli pubblicati su quotidiani o periodici.
Il primo capitolo, “Un’esigenza di totalità” (pp. 185-213), consta di cinque interviste:
- “Comunione e Liberazione: la Chiesa come fatto sociale” (pp. 185-192), a cura di Antonio Maria Baggio, pubblicata in Città Nuova (“Comunione e Liberazione: la Chiesa come fatto sociale: Intervista con mons. Luigi Giussani”, 7, 1986: pp. 26-29);
- “Non compie tutto il suo dovere chi fa solo il suo dovere” (pp. 193-195), pubblicata su Il grano (luglio 1986: p. 5) con il titolo “In politica liberi dal potere”. Come si evince dal cappello introduttivo dell’articolo, si tratta di una ripubblicazione di un’intervista rilasciata alla rivista Città e Società.
- “Sussidiarietà per la vita del popolo” (pp. 196-203), intervista rilasciata ad Alessandro Banfi sul tema della politica, in cui Giussani approfondisce alcune questioni e risponde a obiezioni scaturite in seguito al suo intervento all’Assemblea della DC lombarda ad Assago nel 1987 (qui pubblicato alle pagine 165-170; cfr. Alberto Savorana, Vita di don Giussani, Rizzoli, 2013, pp. 735-738). L’intervista uscì in Il Sabato (maggio 9, 1987, pp. 3-4) con il titolo “La politica, per chi, per che cosa” e fu poi riproposta senza variazioni e con lo stesso titolo nel volumetto La politica per chi per che cosa: Più società meno stato: Antologia per una dottrina sociale (supplemento a Il Sabato, maggio 30, 1987, pp. 13-21);
- “Noi cattolici senza complessi” (pp. 203-207), a cura di Gianluigi Da Rold, pubblicata sul Corriere della Sera (18 settembre 1987, p. 3);
- “CL e la politica” (pp. 207-213), pubblicata per la prima volta nel fascicolo “Società & Cultura” del quotidiano La Stampa (20 settembre 1989, p. 1) con il titolo “Giussani: CL e la politica”.
Il secondo capitolo, “Popolo e potere”, (pp. 214-226) raccoglie tre interviste.
Le prime due, rilasciate a Lourdes al termine del pellegrinaggio di ringraziamento nel decimo anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (17 ottobre 1982) (cfr. Alberto Savorana, Vita di don Giussani, Rizzoli, 2013, pp. 855-858), sono:
- “Il potere egoista odia il popolo” (pp. 214-219), a cura di Gianluigi Da Rold per il Corriere della Sera (“Don Giussani: il potere egoista odia il popolo”, 18 ottobre 1992, p. 3). Il mese successivo il testo è rieditato in CL-Litterae Communionis con il titolo “Un problema di metodo” (11, 1992: pp. 60-63. Con successive traduzioni) e nel 1993, dopo una lieve revisione, diviene parte della miscellanea L’avvenimento cristiano: Uomo Chiesa Mondo con il titolo “Don Giussani: il potere egoista odia il popolo” (BUR, 1993, pp. 125-130; nuova edizione: BUR, 2003).
- “Il potere contro il popolo” (pp. 219-221), a cura di Mario Baudino, è pubblicata con il titolo “Giussani processa l’Italia: È un paese intossicato” in La Stampa (18 ottobre 1992, p. 6).
- La terza, “Un evento, ecco perché ci odiano” (pp. 221-226), è un’intervista di Renato Farina pubblicata in Il Sabato con il titolo “Un evento. Per questo ci odiano” (aprile 25, 1992, pp. 14-15. Con successive traduzioni), successivamente riproposta senza variazioni nella miscellanea Un avvenimento di vita cioè una storia (EDIT: Il Sabato, 1993, pp. 103-107) con il titolo “Un evento, ecco perché ci odiano” e infine nel volume curato da Renato Farina Un caffè in compagnia: Conversazioni sul presente e sul destino, con il titolo “Un evento. Per questo ci odiano” (Rizzoli, 2004, pp. 123-128).
Il terzo capitolo si intitola “Quella baldanza ingenua” (pp. 227-262).
- “Giustizia e perdono” (pp. 227-231) è la ripubblicazione di un testo edito con lo stesso titolo in Il Sabato (giugno 19, 1993, pp. 84-87). Si tratta di un estratto dalla pubblicazione 74 domande risposte (supplemento a CL-Litterae Communionis, 6, 1993: pp. 26-31. Con successive traduzioni), che raccoglie per argomento domande e tracce di possibili risposte nate dalla conversazione tra alcuni responsabili del movimento e don Giussani durante gli Esercizi spirituali di CLL e della Fraternità (Rimini, 2/4 aprile 1993) dal titolo “Questa cara gioia sopra la quale ogni virtù si fonda...”. Le pagine qui riportate corrispondono al capitolo ottavo intitolato “Compito e moralità” (vi sono lievi differenze riguardanti la formulazione e l’ordine di alcune domande poste all’Autore).
- “La baldanza poggia sulla certezza” (pp. 232-246) è il testo di un’intervista a cura di Michele Fazioli (in collaborazione con la RTSI, Radiotelevisione svizzera), pubblicata con il titolo “Quella baldanza ingenua che viene dalla fede” sul quotidiano di Lugano Il Giornale del Popolo (5-6 gennaio 1995, pp. 2-3) e riproposta integralmente in Litterae Communionis-Tracce (3, 1995: inserto. Con successive traduzioni). Nella versione del testo pubblicata nella miscellanea Marietti sono stati espunti il ringraziamento finale a Giussani e la sua risposta.
- “Preghiamo per l’Italia in pericolo” (pp. 246-253) è l’intervista a cura di Pierluigi Battista pubblicata in La Stampa (4 gennaio 1996, p. 5), a partire dalla situazione politica, dalla crisi interna italiana e dal venir meno della Democrazia Cristiana in seguito a Tangentopoli. Il testo è riproposto pochi giorni dopo sul settimanale Tempi con il titolo “Troppo forte è il legame dei vivi coi vivi ... perchè riconosca la validità di chiusi confini. (C. Milosz)” (gennaio 17, 1996, pp. 2-5). Con il titolo usato da La Stampa è ripubblicata identica in 30 Giorni (2, 1996: pp. 41-44. Con successive traduzioni), in Corriere delle Opere (1, 1996: p. 6-7) e in Litterae Communionis-Tracce (4, 1999: pp. 12-15).
Seguono due interviste a cura di Luigi Amicone:
- “Ripartire dall’io” (pp. 253-258), pubblicata in Tempi con il titolo “Non conformatevi” (settembre 3, 1997, pp. I-IV) e successivamente in Litterae Communionis-Tracce con il titolo “Ripartire dall’io” (8, 1997: pp. 91-92. Con successiva traduzione). Il colloquio inizia riprendendo quanto detto dall’Autore nell’intervista “Preghiamo per l’Italia in pericolo” (cfr. Marietti, 2000, pp. 246-253).
- “Vivere il cammino cristiano” (pp. 259-262), concessa dall’Autore al termine della XX edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli (“L’ignoto genera paura, il Mistero genera stupore”), pubblicata sul settimanale Tempi con il titolo “Laici, come il Papa e Clinton” (settembre 2, 1999, pp. 6-7). Il testo è rieditato senza variazioni in Litterae Communionis-Tracce con il titolo “La libertà di un tentativo” (8, 1999: pp. 14-15. Con successiva traduzione), in 30 Giorni con il titolo “Amore allo spazio della libertà” (9, 1999: pp. 26-27. Con successive traduzioni) e con il titolo “La libertà di un tentativo. Intervista di Luigi Amicone a Don Luigi Giussani a conclusione del Meeting” in L’ignoto genera paura. Il Mistero genera stupore: Il libro del Meeting ’99 (Itaca, 1999, pp. 337-338).
Il quarto capitolo si intitola “Spiritualmente semiti” (pp. 263-275) e riporta tre testi originariamente pubblicati su La Repubblica:
- “Il dio denaro e la morte di Cristo” (pp. 263-265), lettera che Giussani invia a Ezio Mauro, direttore del quotidiano, l’11 aprile 1998 (p. 13), in occasione della Pasqua, nella quale esprime le sue preoccupazioni relativamente al momento storico. Nei mesi successivi la lettera è rieditata con lo stesso titolo in 30 Giorni (4, 1998: pp. 78-79. Con successive traduzioni) e in Litterae Communionis-Tracce (5, 1998: p. 88. Con successive traduzioni).
- “La ragione contro il potere” (pp. 266-268), pubblicato il 24 ottobre 1998 (p. 13), è un articolo in cui l’Autore riflette sull’enciclica di papa Giovanni Paolo II Fides et ratio (15 ottobre 1998), pubblicata in occasione del ventesimo anniversario della Sua elezione al soglio pontificio; il testo è rieditato senza variazioni e con lo stesso titolo in Litterae Communionis-Tracce (10, 1998: p. 33. Con successive traduzioni), in 30 Giorni (11, 1998: pp. 90-91. Con successive traduzioni) e nel periodico Documenta: Materiali di lavoro per insegnanti di religione (1, 1999: pp. 31-33).
- “Noi siamo degli ebrei” (pp. 268-270) è una lettera che Giussani invia a Ezio Mauro il 21 dicembre 1998, nel giorno in cui apprende che una bomba, esplosa nel cimitero ebraico di Berlino, ha gravemente danneggiato la tomba di Heinz Galinski, una delle figure più rappresentative dell’ebraismo tedesco (cfr. Alberto Savorana, Vita di don Giussani, Rizzoli, 2013, pp. 1042-1043). La lettera viene pubblicata il 2 gennaio 1999 (p. 13) e subito riportata con lo stesso titolo in Litterae Communionis-Tracce (1, 1999: p. 1. Con successive traduzioni) e in 30 Giorni (1, 1999: pp. 94-95. Con successive traduzioni).
Il quinto e ultimo capitolo dal titolo “Il valore di alcune parole che segnano il cammino cristiano” (pp. 271-275) riporta l’articolo omonimo pubblicato in L’Osservatore Romano il 6 aprile 1996 (p. 4) e riproposto in Litterae Communionis-Tracce (5, 1996: inserto. Con successive traduzioni).
Nel 2005 il testo è ripubblicato in Litterae Communionis-Tracce, nel numero della rivista uscito subito dopo la morte di Giussani e a lui interamente dedicato (“Don Luigi Giussani, 15 ottobre 1922 - 22 febbraio 2005.” Litterae Communionis-Tracce, 3, 2005: pp. 74-75).
Il volume si chiude con le “Fonti” (pp. 277-281) e gli indici (pp. 282-294). [C. C.]