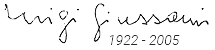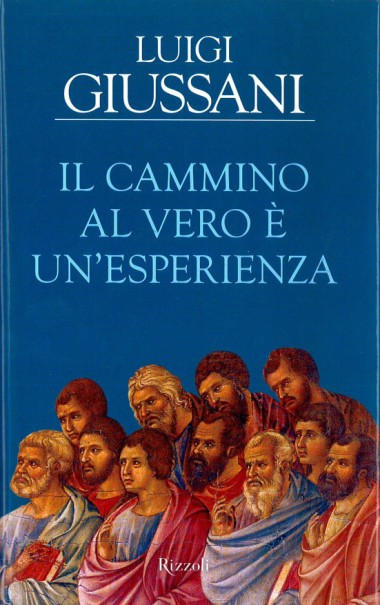Il presente volume è l’edizione in veste definitiva del testo omonimo pubblicato per la prima volta da SEI nel 1995 e riproposto l’anno successivo in edizione speciale, in allegato al mensile 30 Giorni (7/8, 1996), con l’aggiunta della Prefazione appositamente redatta da Christoph Schönborn.
In occasione della pubblicazione Rizzoli (2006) sono state apportate lievi revisioni all’edizione SEI (1996): sono stati corretti i refusi e uniformati i criteri redazionali di titolazione dei capitoli e dei paragrafi; gli indici e l’apparato note sono stati creati ex novo (le citazioni contenute nel testo sono state portate in nota a piè di pagina).
Il cammino al vero è un’esperienza raccoglie i tre scritti che «documentano le ragioni e le conseguenti notazioni metodologiche che accompagnarono il formarsi delle prime comunità d’ambiente» agli inizi del movimento di Comunione e Liberazione, allora detto di Gioventù Studentesca (dall’“Introduzione”, Rizzoli, 2006, p. 11); nel riproporli è stata posta particolare attenzione al rispetto della struttura originale dei testi.
Il volume si apre con la Prefazione di Schönborn (pp. 5-8; con lievi modifiche rispetto alla versione del 1996 apportate in seguito alla morte di Giussani, avvenuta nel 2005).
I testi sono preceduti dall’“Introduzione” dell’Autore all’edizione SEI (1995) dal titolo “La nascita di un’esperienza” (2006, pp. 9-16; SEI, 1995, pp. VII-XII).
Nati spesso come appunti delle lezioni tenute la domenica mattina nella sede dell’A.C. a Milano, com’è detto nella stessa introduzione, i tre scritti sono «riflessioni sopra un’esperienza»; così, infatti, recita il titolo del primo, fondamentale libretto qui riportato: “Gioventù Studentesca. Riflessioni sopra un’esperienza” (pp. 19-80). Si tratta del volumetto G.S. riflessioni sopra un’esperienza, pubblicato nel 1963 (Editrice Nuova Favilla; ripubblicato senza variazioni nel 1964, pro manuscripto a cura di Gioventù Studentesca; la prima edizione, più sintetica, è del 1959).
Nel 1972, Jaca Book ripubblica l’edizione del 1963 in Tracce d’esperienza e appunti di metodo cristiano, volume che ripropone, in versione originale, i tre scritti ora contenuti in Il cammino al vero è un’esperienza.
Nel 1977, la parte iniziale “Direttive metodologiche per il richiamo” (1963, pp. 5-37; Rizzoli, 2006, pp. 25-53) diventa la terza appendice, dal titolo “Aspetti metodologici del richiamo cristiano”, del volume Tracce d’esperienza cristiana e altri scritti (Jaca Book, 1977, pp. 135-171; nuova edizione, 1991, pp. 87-108; rieditato in Opere: 1966-1992: Vol. 2, Jaca Book, Milano 1994, pp. 131-152, secondo dei due volumi che raccolgono gli scritti di Giussani editi da Jaca Book).
Nel 1996, in seguito alla prima edizione di Il cammino al vero è un’esperienza, quella stessa parte (“Direttive metodologiche per il richiamo”, in SEI, 1995, pp. 3-4; Rizzoli, 2006, pp. 25-53) è stata ripubblicata in Litterae Communionis-Tracce con il titolo “Noi impariamo osservando la realtà; non applichiamo nostre idee alla realtà” (2, 1996: inserto. Con successive traduzioni).
Nel 2006, con l’edizione Rizzoli, sono stati inoltre reintegrati i testi “Premessa alla prima edizione” (2006, p. 21; redatto per l’edizione 1959) e “Premessa alla terza edizione” (2006, p. 23; redatto per l’edizione 1963) che erano stati espunti dai volumi SEI (1995 e 1996).
Il secondo testo è “Tracce d’esperienza cristiana” (pp. 81-125), pubblicato a Milano nel 1960 (Tracce d’esperienza cristiana, GIAC e Gioventù Studentesca, 1960).
Dopo la riedizione del 1972 (pp. 77-140), di cui sopra, Jaca Book l’ha riproposto integralmente nel volume Tracce d’esperienza cristiana e altri scritti (1977, pp. 13-88; nuova edizione 1991, pp. 15-60; rieditato in Opere: 1966-1992: Vol. 2, Jaca Book, 1994, pp. 61-104).
“Tracce d’esperienza cristiana” (SEI, 1996, pp. 45-75; Rizzoli, 2006, pp. 81-125) è stato inoltre oggetto di riflessione in conversazioni fra l’Autore e alcuni membri dell’associazione Memores Domini raccolte nei volumi della serie “Quasi Tischreden”; in particolare in «Tu» (o dell’amicizia) (BUR, 1997, T61, T64 e T75), Vivendo nella carne (BUR, 1998, T57 e T68), L’attrattiva Gesù (BUR, 1999, T86; nuova edizione BUR Rizzoli, 2025), Affezione e dimora (BUR, 2001, T73 e T76) e Una presenza che cambia (BUR, 2004, T48).
Il volume si chiude con “Appunti di metodo cristiano” (pp. 127-206. Appunti di metodo cristiano, pro manuscripto a cura di Gioventù Studentesca, 1964; riedizione Jaca Book, 1972, pp. 141-254).
I capitoli “Una grande premessa” (2006, pp. 129-133) e “L’incontro” (2006, pp. 135-157) sono stati pubblicati anche nel volume Tracce d’esperienza cristiana e altri scritti (Jaca Book, 1977) con i titoli “Una premessa di metodo” (pp. 91-99) e “L’incontro” (pp. 101-133; riedizione Jaca Book, 1991, pp. 63-85; Jaca Book, 1994, pp. 107-129).
Per quanto riguarda il paragrafo “L’incontro come grazia” (2006, pp. 151-155), nel 1991 il mensile 30 Giorni ne propone il contenuto a introduzione della traduzione integrale del Decreto sulla giustificazione, approvato nella sessione VI del Concilio di Trento del 1547 (“L’incontro come grazia”, 30 Giorni, 4, 1991: pp. 36-37. Con successive traduzioni). Nel 2012, la rivista ripubblica lo scritto dell’Autore a commento del capitolo I e dei canoni 1 e 5 del medesimo decreto (“L’incontro come Grazia”, 30 Giorni, 1/2, 2012: pp. 4-12. Con successive traduzioni). Il testo presenta alcune differenze rispetto alla precedente edizione del 1991, in quanto ha subito una lieve revisione in occasione della ripubblicazione in veste definitiva nella presente miscellanea, da cui è tratto.
Nel 1993, questo stesso paragrafo è stato pubblicato a “Conclusione” del volume miscellaneo Un avvenimento di vita, cioè una storia: Itinerario di quindici anni concepiti e vissuti: Interviste, conversazioni, interventi di monsignor Luigi Giussani a partire da registrazioni, non rivisti dall’autore (a cura di Carmine Di Martino. EDIT: Il Sabato, 1993, pp. 463-469).
Il paragrafo “L’incontro come esperienza” (punti 1, 2, 3 - 2006, pp. 156-157) ripropone parte del fascicolo L’esperienza (“L’esperienza cristiana”, in 1963, pp. 8-9) che è poi diventato la sezione “Struttura dell’esperienza” del volume Il rischio educativo (Jaca Book, 1977, pp. 89-95; riedizione Jaca Book, 1988, pp. 93-99; Opere: 1966-1992: Vol. 2, Jaca Book, 1994, pp. 539-545; Il rischio educativo: Come creazione di personalità e di storia, SEI, 1995, pp. 53-56; Rizzoli, 2005, pp. 126-131). Nel 2002, lo scritto è stato riproposto integralmente in Litterae Communionis-Tracce con il titolo “L’esperienza” (4, 2002: inserto. Con successive traduzioni).
Nel 1997, entrambi i paragrafi sopra citati sono riproposti nel capitolo “Un’esperienza educativa” del volume La gloria di Cristo ovvero la Sua vittoria nel tempo: I dogmi sulla grazia, a cura di Lorenzo Bianchi (SEI: 30 Giorni, 1997, pp. 141-145, pp. 147-149).
Il paragrafo “Democrazia” (2006, pp. 189-193), parte del capitolo “Missione”, è stato pubblicato anche nel volume miscellaneo L’io, il potere, le opere: Contributi da un’esperienza (“Affermare l’altro in quanto è”, in Marietti, 2000, pp. 179-182. Con successive traduzioni).
Da aprile 2008 il volume è disponibile anche in edizione economica “BUR Saggi” (si tratta di una ristampa conforme all’edizione Rizzoli, 2006).
Il 26 marzo 2016, per iniziativa editoriale di RCS: Corriere della Sera, Il cammino al vero è un’esperienza esce in abbinamento al quotidiano nella collana “I manuali del Corriere della Sera”. Si tratta del sesto di dieci volumi dell’Autore in edicola settimanalmente.
Ogni volume è introdotto da una nuova presentazione; per Il cammino al vero è un’esperienza l’autore è Gualtiero Bassetti (pp. I-VII).
Il testo di Giussani è una ristampa conforme all’originale dell’edizione Rizzoli, 2006, comprensiva della Prefazione dell’allora arcivescovo di Vienna Christoph Schönborn (2016, pp; 5-8; Rizzoli, 2006, pp. 5-8). [P. M]