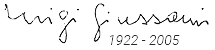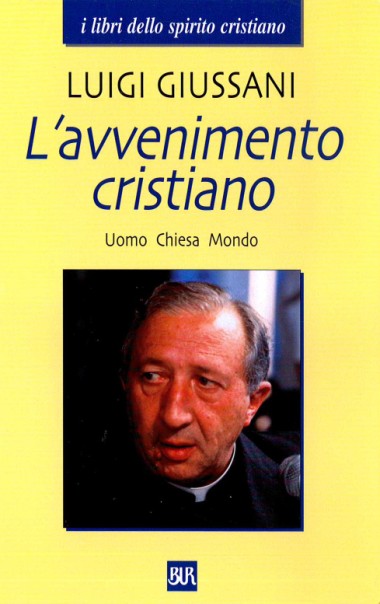Nel 2003 Rizzoli ripubblica integralmente il volume miscellaneo L’avvenimento cristiano: Uomo Chiesa Mondo (1993, BUR “Supersaggi”) nella collana BUR “I libri dello spirito cristiano”. In tale occasione il testo è rivisto e vengono aggiunti l’apparato note (pp. 131-139), le fonti bibliografiche (pp. 141-144) e gli indici tematici (pp. 145-155).
Il volume è diviso in tre sezioni.
La “Parte prima. La libertà dell’uomo e l’avvenimento cristiano” comprende gli scritti “Il cristianesimo: incontro umano” (2003, pp. 7-25), testo inedito dell’intervento dell’Autore alla Giornata d’inizio anno degli universitari (Milano, 27 ottobre 1992), e “Dal Battesimo una creatura nuova” (pp. 23-25), intervento al Sinodo dei Vescovi sui laici (Roma, 9 ottobre 1987), uscito integralmente sull’agenzia di stampa ADISTA con il titolo “Mons. Giussani: Comunione vivente col Papa, luogo dell’ultima pace per ogni fedele” (22-24 ottobre 1987).
La sintesi dell’intervento è stata pubblicata in L’Osservatore Romano (11 ottobre 1987) e in CL-Litterae Communionis con il titolo “I movimenti ecclesiali forme storiche per la missione della Chiesa” (11, 1987: p. 5. Con successive traduzioni).
Nel 1997, a dieci anni dal Sinodo, Litterae Communionis-Tracce ha riproposto il testo nella versione più ampia pubblicata da ADISTA, unitamente all’omelia e al discorso di Giovanni Paolo II ai Padri Sinodali del 30 ottobre 1987 (“Dal Battesimo un protagonista nuovo” in Litterae Communionis-Tracce, 9, 1997: p. 51). Nel 2005, l’intervento dell’Autore è pubblicato con il titolo “Dal battesimo una creatura nuova” nel numero di Litterae Communionis-Tracce interamente dedicato a Giussani dopo la sua morte (“Don Luigi Giussani, 15 ottobre 1922 - 22 febbraio 2005”, 3, 2005: p. 86).
La “Parte seconda”, intitolata “La Chiesa, corpo vivo di Cristo”, raggruppa i seguenti interventi:
- “Come nasce un movimento” (pp. 29-50), intervento di Giussani alle vacanze internazionali di CL (Corvara, agosto 1989), già pubblicato con lo stesso titolo nel mensile 30 Giorni (2, 1990: pp. 4-13. Con successive traduzioni), nella miscellanea Un avvenimento di vita, cioè una storia: Itinerario di quindici anni concepiti e vissuti: Interviste, conversazioni, interventi di monsignor Luigi Giussani a partire da registrazioni, non rivisti dall’autore (a cura di Carmine Di Martino. EDIT: Il Sabato, 1993, pp. 394-412) e nel volume Comunione e Liberazione: Un movimento nella Chiesa (a cura di Davide Rondoni. Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, 1998, pp. 71-85. Con successive traduzioni). Nel 2022, in occasione del Centenario della nascita dell’Autore, la parte corrispondente al paragrafo “«E il Verbo si è fatto carne»” (pp. 30-33) è stata ripubblicata con il titolo “Il bel giorno” in Litterae Communionis-Tracce (9, 2022: pp. 11-13. Con successive traduzioni);
- “Memoria, non devoto ricordo” (pp. 51-57), testo di una meditazione per il Giovedì Santo tenuta da Giussani agli universitari (Certosa di Pavia, 8 aprile 1993), già pubblicata con lo stesso titolo in CL-Litterae Communionis (5, 1993: inserto. Con successive traduzioni);
- “L’avvenimento implica un metodo” (pp. 59-63), testo dell’intervento all’Assemblea responsabili di CL (Milano, 24 novembre 1992; nelle “Fonti” l’evento è erroneamente datato 10 ottobre 1992; BUR, 2003, p. 142), già pubblicato su CL-Litterae Communionis (1, 1993, inserto. Con successive traduzioni) con il titolo “L’avvenimento è un metodo” (nel testo BUR è stato espunto il cappello introduttivo);
- “Il sacrificio più grande è dare la propria vita per l’opera di un Altro” (pp. 65-70), testo dell’intervento dell’Autore al Consiglio nazionale dei responsabili di CL (Milano, 15 febbraio 1992), pubblicato con lo stesso titolo in CL-Litterae Communionis (4, 1992: inserto), nel libretto Dalla fede il metodo: Conversazioni di Luigi Giussani: 1992-1994 (Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, 1994, pp. 25-28), in forma parziale nel numero di Litterae Communionis-Tracce interamente dedicato a Giussani dopo la sua morte (“Don Luigi Giussani, 15 ottobre 1922 - 22 febbraio 2005”, 3, 2005: pp. 78-79) e, integralmente, in Litterae Communionis-Tracce (4, 2005: pp. 1-7);
- “L’appartenenza sorgente di moralità e di cultura” (pp. 71-77), sintesi dell’intervento di Giussani alla Giornata di fine anno degli adulti di CL (Milano, 30 maggio 1992), testo pubblicato con lo stesso titolo in CL-Litterae Communionis (7/8, 1992, inserto. Con successive traduzioni). Una versione più ampia e dettagliata dello stesso intervento era stata pubblicata nel giugno dello stesso anno con il titolo Appartenere a Cristo oggi. Appunti di un approccio al problema presi in una conversazione con don Luigi Giussani: Milano, 30 maggio 1992 (supplemento a Il Sabato, giugno 27, 1992, pp. 12-31).
La terza e ultima parte è intitolata “La fede e le opere”. Fatta eccezione per il primo scritto, in essa sono proposti alcuni interventi dell’Autore alle assemblee nazionali della Compagnia delle Opere (CdO):
- “La carità costruisce per sempre” (pp. 81-86) è il testo dell’intervento dell’Autore al convegno “Nella carità la solidarietà diventa opera” (Tarcento, 25 ottobre 1986), svoltosi in occasione del decennale del terremoto in Friuli. Si segnala che in “Appendice” (p. 142) lo scritto viene erroneamente definito come esito di una conversazione con alcuni adulti del Friuli; si tratta invece del suo contributo al convegno (dato reperito presso l’Archivio della Fraternità di Comunione e Liberazione). Lo scritto è stato pubblicato con lo stesso titolo in CL-Litterae Communionis (2, 1987: pp. 22-24. Con successive traduzioni) e successivamente è stato rieditato come “La carità si fa opera” in Il lavoro dell’uomo: Interventi di monsignor Luigi Giussani (EDIT, 1988, pp. 17-21. Con successive traduzioni) e nella miscellanea L’io, il potere, le opere: Contributi da un’esperienza col titolo “Di fronte al bisogno” (Marietti, 2000, pp. 124-129. Con successive traduzioni). Nel settembre 2022, successivamente alla morte di don Antonio Villa, il testo è riproposto con il titolo “La carità costruisce per sempre” sul sito web di Comunione e Liberazione (https://it.clonline.org/news/attualit%C3%A0/2022/09/14/morte-Antonio-Villa-Don-Giussani-1986+.Verificato in data 10/06/2024. Con successiva traduzione);
- “Vivere con gioia la terra del Mistero” (pp. 87-91) è la sintesi di un intervento dell’Autore alla prima Assemblea nazionale della CdO (Milano, 5 dicembre 1987), pubblicata, con lo stesso titolo e senza variazioni, in Il lavoro dell’uomo (EDIT, 1988, pp. 23-26. Con successive traduzioni), in Le opere: “La fede senza le opere è morta” (Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, 1989, pp. 18-19, “Grandi Quaderni di Litterae Communionis 4”), in Corriere delle Opere (7, 1991: p. 8-9) e nella miscellanea L’io, il potere, le opere: Contributi da un’esperienza con il titolo “Dal cuore il lavoro, dal lavoro l’opera” (Marietti, 2000, pp. 91-95);
- “Le opere: realismo e creatività della fede” (pp. 93-101; CdO, Milano, 4 marzo 1989) è stato pubblicato con lo stesso titolo in CL-Litterae Communionis (4, 1989: pp. 8-11. Con successive traduzioni), riproposto identico nel fascicolo intitolato Le opere: “La fede senza le opere è morta” (Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, 1989, pp. 20-23, “Grandi Quaderni di Litterae Communionis 4”), in Corriere delle Opere (7, 1991: pp. 10-12) e nel volume L’io, il potere, le opere: Contributi da un’esperienza (secondo paragrafo del capitolo “La compagnia si dilata in libertà”, Marietti, 2000, pp. 154-161);
- “Veramente utili alla compagnia umana” (pp. 103-110; CdO, Milano, 26 gennaio 1991) è stato pubblicato con il titolo “La felicità e le opere” in Corriere delle Opere (3, 1991: pp. II-IV), con il titolo “Perché tu sia felice” in CL-Litterae Communionis (3, 1991: inserto. Con successive traduzioni), con il titolo “Veramente utili alla compagnia umana” in Corriere delle Opere (7, 1991: pp. 13-15) e nella miscellanea L’io, il potere, le opere: Contributi da un’esperienza (primo paragrafo del capitolo “La compagnia si dilata in libertà”, Marietti, 2000, pp. 148-154).
“Le opere nascono solo quando uno ha il coraggio di dire «io»” (pp. 111-115; CdO, Milano, 14 marzo 1992) è stato pubblicato con lo stesso titolo nel fascicolo Intanto qualcuno costruisce (atti del convegno, supplemento al Corriere delle Opere, 3, 1992: pp. 5-8), in CL-Litterae Communionis (5, 1992: inserto) e in L’io, il potere, le opere: Contributi da un’esperienza (Marietti, 2000, p. 99-102).
- “Una passione per l’uomo” (pp. 117-121; CdO, Milano, 6 febbraio 1993) è stato pubblicato con lo stesso titolo nel fascicolo Una tensione ideale (atti del convegno, supplemento a Corriere delle Opere, 4, 1993: pp. 7-10) e in L’io, il potere, le opere: Contributi da un’esperienza (Marietti, 2000, pp. 129-133. Con successive traduzioni) con il titolo “Creare una casa più abitabile per l’uomo”.
In “Appendice” è riportata l’intervista all’Autore dal titolo “Don Giussani: il potere egoista odia il popolo” (pp. 125-130), a cura di Gianluigi Da Rold, a conclusione del pellegrinaggio a Lourdes per il decennale del riconoscimento pontificio della Fraternità di CL (17 ottobre 1992) e pubblicata sul Corriere della Sera il 18 ottobre 1992 (p. 3). Il testo è stato rieditato in CL-Litterae Communionis (11, 1992: pp. 60-63. Con successive traduzioni) con il titolo “Un problema di metodo” e, nel 2000, è stato posto in appendice alla miscellanea L’io, il potere, le opere: Contributi da un’esperienza (Marietti, 2000, pp. 214-219. Con successive traduzioni) con il titolo “Il potere egoista odia il popolo”. [P. M.]