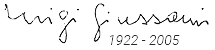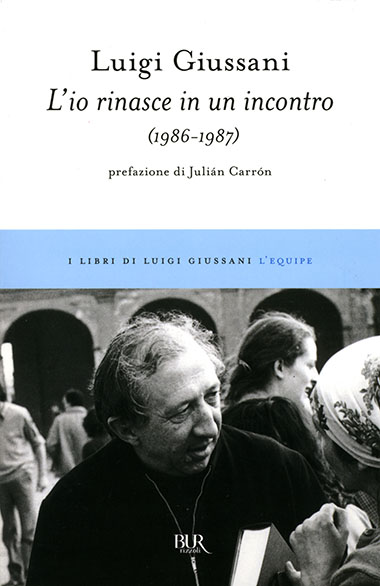Volume miscellaneo che raccoglie interventi e conversazioni di Giussani con i responsabili degli studenti universitari di Comunione e Liberazione svoltisi negli anni 1986 e 1987 (Equipe del CLU); si tratta del quinto volume della serie “L’Equipe” edito nella nuova collana “I libri di Luigi Giussani”.
I testi, raccolti in ordine cronologico, sono preceduti dalla prefazione La rinascita dell’io, redatta da Julián Carrón (pp. I-XIV).
Ogni Equipe è anticipata da una nota storica a cura di Onorato Grassi (in corsivo nel testo) che contestualizza l’evento; in occasione della redazione del presente volume tutti gli scritti sono stati rivisti sulla base della documentazione, scritta e audio, conservata nell’Archivio della Fraternità di Comunione e Liberazione. È stata mantenuta la forma orale dei dialoghi e delle conversazioni (p. 6).
1986
“Una storia” (pp. 7-56) raccoglie i testi inediti di due incontri svoltisi durante l’Equipe che ebbe luogo dal 18 al 20 gennaio 1986 a Riva del Garda: “Assemblea” (pp. 8-36) e “Sintesi” (pp. 37-56).
Il capitolo “Il punto rosso” (pp. 57-146) riporta gli interventi di Giussani e i dialoghi con gli studenti avvenuti durante l’Equipe tenutasi a Corvara dal 20 al 25 agosto 1986: “Introduzione” (pp. 59-62), “Lezione” (pp. 63-86), “Assemblea” (pp. 87-114), “Serata su Clemente Rebora” (pp. 115-127) e “Sintesi” (pp. 128-146). Precede gli scritti il testo del Volantone per la Pasqua 1986 (pp. 58-59), si tratta di una citazione di Joseph Ratzinger dal volume Introduzione al cristianesimo (Queriniana, 2005, p. 82; prima edizione 1968).
1987
In “Chernobyl” sono proposti i testi di due incontri svoltisi a Rimini tra il 31 gennaio e il 2 febbraio 1987: “Assemblea”, testo inedito che riporta integralmente la conversazione tra l’Autore e gli studenti (pp. 150-180), e “Sintesi” (pp. 181-196).
Della “Sintesi” (pp. 181-196) esistono precedenti pubblicazioni in forme diverse:
- nel maggio 1987, un sunto dell’intervento di Giussani è pubblicato in CL-Litterae Communionis con il titolo “La persona contro il potere” (5, 1987: pp. 14-17. Con traduzioni); nel 2000, il testo sarà riproposto senza variazioni nel volume miscellaneo L’io, il potere, le opere: Contributi da un’esperienza con il titolo “Tra Barabba e lo schiavo frigio” (Marietti, 2000, pp. 39-43. Con successive traduzioni);
- nel luglio 1987, la rivista Il Sabato pubblica l’intervento di Giussani con il titolo “Come parlare di Cristo ai giovani” (Il Sabato, luglio 25, 1987, pp.19-20), in una forma molto più ampia rispetto a quella precedentemente uscita su CL-Litterae Communionis; in questa stessa forma lo scritto è rieditato nel volumetto Si ricomincia da Uno: Appunti da conversazioni di monsignor Luigi Giussani con gli universitari di Comunione e Liberazione con il titolo “La persona rinasce in un incontro” (supplemento a Il Sabato, dicembre [24], 1988, pp. 67-81. Testo non rivisto dall’Autore);
- nel 1993, il testo edito in Il Sabato (luglio 25, 1987) è pubblicato, dopo revisione, nel volume miscellaneo Un avvenimento di vita, cioè una storia: Itinerario di quindici anni concepiti e vissuti: Interviste, conversazioni, interventi di monsignor Giussani a partire da registrazioni, non rivisti dall’autore (a cura di Carmine di Martino. EDIT: Il Sabato, 1993, pp. 209-217) con il titolo “La persona rinasce in un incontro”; in questa forma e con lo stesso titolo, nel 1997 è riproposto dalla rivista 30 Giorni (3, 1997: pp 39-46. Con traduzioni).
Chiude il capitolo l’“Omelia” pronunciata durante la messa (pp. 197-198).
“La persona e il potere” (pp. 200-257) raccoglie i testi dell’Equipe svoltasi a Rimini dal 16 al 18 maggio 1987.
Il capitolo si apre con il testo del Volantone pubblicato in occasione della Pasqua 1987 (pp. 200-201), che contiene una frase di Václav Bělohradský tratta da “L’epoca degli ultimi uomini”, intervista rilasciata per il periodico L’Altra Europa (6, 1986: p. 5), e una frase tratta dal vangelo di san Matteo (20, 24-28).
Seguono i testi inediti dell’“Assemblea” (pp. 202-235) e della “Sintesi” conclusiva dell’Autore (pp. 236-257).
Il capitolo dal titolo “Tutta la vita” (pp. 259-426) riguarda l’Equipe estiva svoltasi a Corvara dal 20 al 25 agosto 1987.
Il testo si apre con l’“Omelia” (pp. 260-263), a cui fa seguito l’“Introduzione” (pp. 264-288). Nella parte intitolata “Comunicazione” (pp. 289-295) Giussani riferisce dell’incontro che ebbe con papa Giovanni Paolo II a Castel Gandolfo tre giorni prima dell’Equipe del CLU, e dell’invito ricevuto dal Santo Padre a partecipare al Sinodo dei Vescovi, in programma a Roma nell’ottobre del 1987.
Segue “Assemblea 1” (pp. 296-339), che riporta la conversazione che l’Autore ebbe con gli universitari a partire dall’intervista, a cura di Angelo Scola, “Il «potere» del laico, cioè del cristiano” pubblicata sulla rivista 30 Giorni (8, 1987: pp. 39-51. Con successive traduzioni). L’assemblea si chiude con un intervento di Václav Bělohradský, filosofo cecoslovacco, a quel tempo docente di Sociologia all’Università di Genova, autore della frase scelta per il Volantone di Pasqua di quell’anno, incentrata sul rapporto tra la persona e il potere.
Durante la “Serata su Emmanuel Mounier” (pp. 340-347) Giussani lesse e commentò alcune lettere di Emmanuel Mounier alla moglie. Il testo qui proposto non è una prima pubblicazione, nel 1996, infatti, era già stata editato nel volume miscellaneo Le mie letture con il titolo “Ravvivare l’umano” (BUR, 1996, pp. 161-167; BUR, 2008, pp. 163-169. Con successive traduzioni). Lo scritto riportato nella presente opera si differenzia in alcune parti da quello contenuto in Le mie letture perché, come in tutti i volumi della serie, è posta particolare attenzione alla forma orale originale dei dialoghi stabilita sulla base della documentazione scritta e audio conservata nell’Archivio della Fraternità di Comunione e Liberazione.
Seguono i testi inediti di “Assemblea 2” (pp. 348-405) e “Assemblea 3” (pp. 406-426).
Una sintesi delle assemblee è riportata nell’articolo, senza firma dell’Autore, intitolato “Comunione è Liberazione” in CL-Litterae Communionis (10, 1987: pp. 14-18. Con successive traduzioni).
In “Appendice” sono raccolti i testi dei primi Volantoni di Pasqua: “Pasqua 1982. Cristo la compagnia di Dio all’uomo” (pp. 429-433), “Pasqua 1983. Le Christ est ressuscité” (pp. 434-435), “Pasqua 1984” (p. 436) e “Pasqua 1985” (p. 437).
Il volume si chiude con la “Legenda” (pp. 439-442), gli “Indici” (pp. 443-459) e il “Sommario” (pp. 461-462). [C. C.]