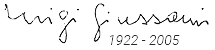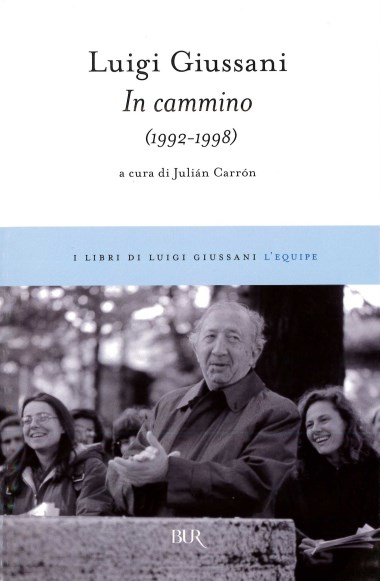Volume miscellaneo che raccoglie interventi e conversazioni di Giussani con i responsabili degli studenti universitari di Comunione e Liberazione svoltisi tra il 1992 e il 1998 (Equipe del CLU). Si tratta dell’ottavo volume della serie “L’Equipe” edito nella collana “I libri di Luigi Giussani”.
I testi, raccolti in ordine cronologico, sono preceduti dalla prefazione L’unica risorsa: il senso cristiano dell’io, redatta da Julián Carrón (pp. I-XVII).
Ogni Equipe è anticipata da una nota storica a cura di Onorato Grassi (in corsivo nel testo) che contestualizza l’evento; in occasione della redazione del presente volume tutti gli scritti sono stati rivisti sulla base della documentazione, scritta e audiovisiva, conservata presso l’Archivio della Fraternità di Comunione e Liberazione. Come riporta la Nota editoriale (p. 6), per quanto riguarda la forma dialogica delle assemblee e delle conversazioni si è seguito «il criterio della fedeltà a ciò che è stato detto così come è stato detto», perché «condizione essenziale per la comprensione del contenuto esposto dall’Autore»; nel passaggio dalla forma orale alla forma scritta, sono state eliminate espressioni incidentali non essenziali e sono stati esplicitati i riferimenti contenuti nel testo.
1992
Il primo scritto, “Colui per cui si vive” (pp. 9-51), è il testo integrale dell’incontro svoltosi a Milano il 22 marzo 1992.
Il capitolo si apre con l’intervento di Giussani alle Lodi (“Introduzione alle Lodi”, pp. 11-15).
Segue il testo dell’“Assemblea” (pp. 16-38). La prima redazione di questo scritto è stata pubblicata in Litterae Communionis-CL con il titolo “Conversazioni su un’esperienza” (6, 1992: pp. 4-11. Con successive traduzioni); essa differisce in parte dalla stesura proposta nel presente volume (BUR, 2014).
Il testo conclusivo (pp. 38-51) non è l’usuale “sintesi” di Giussani, ma un approfondimento di alcune tematiche emerse nel corso dell’assemblea (l’Autore segnala «i fattori principali del contesto in cui dobbiamo vivere la nostra compagnia»; cfr. p. 38 e p. 51). Quest’ultimo intervento è stato pubblicato per la prima volta, in una forma diversa da quella proposta nella presente edizione, in Il Sabato con il titolo “Colui per cui si vive” (aprile 18, 1992, pp. 88-91. Con successive traduzioni) e rieditato identico l’anno seguente nella miscellanea Un avvenimento di vita, cioè una storia: Itinerario di quindici anni concepiti e vissuti: Interviste, conversazioni, interventi di monsignor Luigi Giussani a partire da registrazioni, non rivisti dall’autore (a cura di Carmine Di Martino. EDIT: Il Sabato, 1993, pp. 319-329). Nel 1996, Il nuovo Areopago ha pubblicato l’articolo “Una presenza visibile” (2, 1996: pp. 99-102), che propone alcuni passaggi tratti dal volume EDIT: Il Sabato, 1993 (pp. 322-326).
“Il dialogo fra di noi” (“Assemblea”, pp. 53-96) è la conversazione fra Giussani e i partecipanti all’Equipe svoltasi a Milano il 27 giugno 1992, qui pubblicata per la prima volta.
“In cammino” (pp. 97-170), testo che dà il titolo al presente volume, riporta quanto detto durante l’Equipe estiva del CLU svoltasi a La Thuile dal 19 al 25 agosto 1992, a cui parteciparono settecento universitari di Comunione e Liberazione provenienti da trentotto nazioni. Fu l’ultimo raduno estivo di questo genere, poiché dall’anno successivo si tenne al suo posto l’incontro internazionale dei responsabili di tutto il movimento di CL (AIR), i cui contenuti furono ripresi nelle Equipe durante l’anno (cfr. la nota storica, pp. 97-98).
L’intervento di Giussani ha avuto una prima diffusione nel 1992 nel libretto In cammino: Appunti da una conversazione di monsignor Luigi Giussani con universitari, agosto 1992 (a cura di Carmine Di Martino. Supplemento a Il Sabato, ottobre 10, 1992. Con successive traduzioni).
L’anno successivo, lo scritto è stato ripubblicato nel volume Un avvenimento di vita, cioè una storia, di cui costituisce l’“Appendice” (EDIT: Il Sabato, 1993, pp. 473-502). L’Autore ha operato un’attenta revisione al testo, che ha portato all’espunzione dei punti introduttivi (In cammino, 1992, pp. 3-4) e alla variazione nella suddivisione di alcuni paragrafi: il primo paragrafo, “Il soggetto costituito” (In cammino, 1992, pp. 5-8), è diventato “La coscienza dell’io impedita” (EDIT: Il Sabato, 1993, pp. 475-477; In cammino, BUR, 2014, pp. 99-102) e comprende il primo dei punti introduttivi intitolato “Il sentimento della propria persona” (In cammino, 1992, p. 3); “Nota. Quasi una parentesi” (In cammino, 1992, p. 26) è diventato il paragrafo 7 dal titolo “L’inizio di un soggetto nuovo” (EDIT: Il Sabato, 1993, pp. 489-493; In cammino, BUR, 2014, pp. 117-122).
Nel 1994, il testo è stato ripubblicato identico all’edizione del 1993 nel volumetto È, se opera: Appunti da conversazioni con dei giovani. Agosto 1992 - settembre 1993 (supplemento a 30 Giorni, 2, 1994: pp. 7-40) e, nel 2000, è stato riproposto in Litterae Communionis-Tracce (“In cammino”, 2, 2000: inserto. Con successive traduzioni).
Nel 1996, alcune pagine tratte da Un avvenimento di vita, cioè una storia (pp. 484-487, p. 497) sono diventate parte dell’articolo “Una presenza visibile” in Il nuovo Areopago (2, 1996: pp. 102-104).
Come affermato da Onorato Grassi (cfr. nota a p. 97), il testo proposto nel volume BUR, 2014 (pp. 99-135) è quello rivisto dall’Autore nella forma pubblicata in Un avvenimento di vita, cioè una storia (EDIT: Il Sabato, 1993).
Seguono due scritti inediti: “Serata di presentazione del film Ordet di Carl Theodor Dreyer” (pp. 136-140) e “Assemblea” (pp. 141-170).
1993-1994
Come si legge nella nota storica (p. 173), i testi che seguono riguardano solo gli incontri nei quali è intervenuto Giussani. Si tratta di raduni che si sono tenuti a Milano nel corso dell’anno accademico, molto partecipati e abbastanza brevi, svolti in modo assembleare con una sintesi finale dell’Autore.
“L’iniziativa di un Altro” (pp. 178-210) è il testo dell’“Assemblea” del 13 marzo 1993, qui pubblicato per la prima volta.
“Riconoscere una Presenza” (pp. 211-238) riporta il testo dell’“Assemblea” (pp. 211-228) e la “Sintesi” dell’Autore (pp. 229-238) relativi all’incontro del 12 giugno 1993.
Nell’estate 1993, un sunto dei contenuti dell’Equipe è stato proposto in 30 Giorni con il titolo “Riconoscere una presenza” (7/8, 1993: pp. 35-46. Con successive traduzioni). In questa forma il testo è pubblicato anche in Litterae Communionis-Tracce (8, 1993: inserto. Con successive traduzioni).
“Lo scopo della scuola di comunità” (pp. 239-241) è il testo del saluto introduttivo di Giussani all’Equipe del 4 marzo 1994, a cui l’Autore non partecipò per sopravvenuti impegni (cfr. la nota storica a p. 239). In quello stesso anno il testo è stato pubblicato in Litterae Communionis-Tracce con il titolo “Scuola e metodo” (10, 1994: p. 9. Con successive traduzioni). Si segnalano lievi differenze di carattere redazionale nella presente edizione (BUR, 2014).
“Amanti della verità” (pp. 243-266) è la “Sintesi” dell’Autore all’incontro del 26 ottobre 1994.
In quello stesso anno, lo scritto è stato pubblicato con il titolo “Equipe universitari” nel libretto Realtà e giovinezza: la sfida: Appunti da conversazioni di Luigi Giussani con un gruppo di universitari e con studenti medi (Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo, 1994, pp. 3-30). L’anno successivo è stato riproposto in forma identica nella miscellanea Realtà e giovinezza. La sfida (SEI, 1995, pp. 94-108).
Nel 2018, in occasione della pubblicazione della nuova edizione di Realtà e giovinezza. La sfida per i tipi di Rizzoli (2018, pp. 119-137), lo scritto sarà rieditato nella forma redazionale definitiva contenuta in In cammino (BUR, 2014).
Dal 1995 in poi
“L’imprevisto della realtà” (pp. 271-308) raccoglie gli interventi durante l’“Assemblea” (pp. 271-298) e la “Sintesi” (pp. 299-308) dell’Autore relativi all’Equipe svoltasi a Milano l’8 novembre 1995. I due testi sono qui pubblicati per la prima volta.
“Vivere la ragione” (pp. 309-335) è il testo dell’assemblea che ha avuto luogo il 21 giugno 1996, a Milano.
Parte del testo della conversazione con gli universitari era già stata pubblicata in Litterae Communionis-Tracce (“Vivere la ragione”, 8, 1996: inserto. Con successive traduzioni); rispetto alla versione edita in BUR, 2014, nell’edizione 1996 mancano due interventi (BUR, 2014, pp. 311-312, p. 315).
Nel 2006, i primi tre interventi degli studenti e le relative risposte dell’Autore (8, 1996: pp. I-VI) sono stati riproposti con il titolo “Vivere la ragione” in Litterae Communionis-Tracce (1, 2006: pp. 1-5. Con successive traduzioni).
“Accettiamo la vita perché tendiamo alla felicità” (pp. 337-346) è la trascrizione dell’assemblea svoltasi il 4 aprile 1998, a Milano.
Nel maggio 1998, Litterae Communionis-Tracce ha pubblicato per la prima volta il testo dell’incontro (5, 1998: inserto. Con successiva traduzione); non sono riportate alcune righe introduttive, presenti invece nel volume BUR, 2014.
Quella del 4 aprile 1998 è l’ultima Equipe degli universitari di CL alla quale Giussani partecipa di persona. Dopo di allora interverrà qualche volta ancora attraverso collegamenti video (cfr. Alberto Savorana, Vita di don Giussani, Rizzoli, 2013, p. 1016), di cui però non esistono testi pubblicati (dato reperito presso l’Archivio di Comunione e Liberazione). Fa eccezione il testo “Unità e fraternità: la sintesi di ogni giorno” (pp. 347-348). Lo scritto è un breve saluto dell’Autore intervenuto in videoconferenza da Milano il 7 settembre 2003, durante l’Equipe svoltasi a La Thuile dal 4 al 7 settembre 2003.
La prima pubblicazione dell’intervento, identica per titolo e forma redazionale a quella riportata in BUR, 2014, si trova in Litterae Communionis-Tracce (9, 2003: pp. 1-2. Con successive traduzioni).
Nel 2004, il testo è divenuto l’introduzione a Una presenza che cambia (BUR, 2004, pp. 3-4), settimo volume della serie “Quasi Tischreden”.
Chiudono il volume la sezione “Appendice” (pp. 351-372), in cui sono proposti i testi dei Volantoni di Pasqua dal 1982 al 1998, la “Legenda” (pp. 373-376) e gli “Indici” (pp. 377-393). [C. C.]