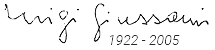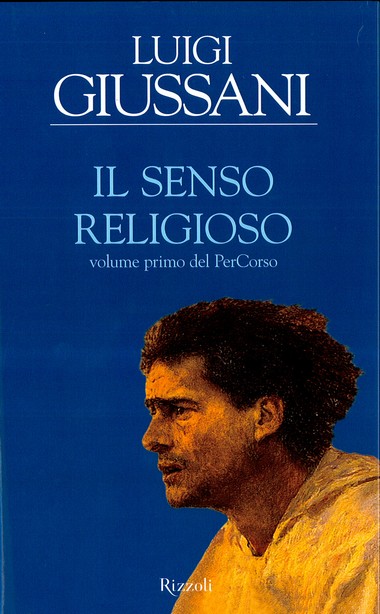Edizione aggiornata del volume Il senso religioso pubblicato da Rizzoli nel 1997 (il testo di Giussani non ha subito modifiche, sono state aggiornate le note).
Il libro si apre con la Prefazione di James Francis Stafford (redatta per l’edizione 1997, modificato l’incipit; pp. V-IX), seguita dall’“Introduzione” dell’Autore (p. XI).
L’Autore si era già occupato di questo tema nel dicembre 1957 con un volumetto (Il senso religioso, GIAC) rivolto ai soci adulti della Gioventù di Azione Cattolica milanese, il cui argomento era in parte dettato dalla lettera pastorale dell’arcivescovo Montini per la Quaresima 1957 intitolata Sul senso religioso (lo scritto di Giussani e la lettera di Montini sono ripubblicati integralmente in Montini, Giovanni Battista, e Giussani, Luigi. Sul senso religioso. BUR, 2009, pp. 45-127).
Nel 1966, Jaca Book edita per la prima volta il volume Il senso religioso che raccoglie organicamente appunti, rivisti dall’Autore, di lezioni tenute al liceo milanese Berchet fra il 1954 e il 1960 circa (collana “Note e sintesi”); lo scritto ottiene l’imprimatur ecclesiastico (Venegoni 16 III 1966 / Nihl obstat quominus imprimatur /sac. Carolus Figini cens. Eccl.).
Nel testo sono riportate e approfondite le tematiche trattate dall’Autore nel 1957. L’edizione 1966 è ora pubblicata in Il senso di Dio e l’uomo moderno: La “questione umana” e la novità del Cristianesimo (BUR Rizzoli, 2010, pp. 7-75. Prima edizione: BUR, 1994).
Nel 1975, Jaca Book ristampa il volume del 1966 nella collana “Richieste 1” senza apportare variazioni al testo (ristampa conforme all’originale, modificati formato e copertina).
Nel 1977, il testo è rieditato senza variazioni nella collana della Jaca Book “Già e non ancora”. La “Nota di edizione” (pp. 7-10) anticipa però un nuovo progetto editoriale: gli argomenti trattati verranno infatti sviluppati nei volumi del perCorso (Il senso religioso: Volume primo del perCorso, 1986; All’origine della pretesa cristiana: Volume secondo del perCorso, 1988; Perché la Chiesa: Tomo 1: La pretesa permane: Volume terzo del perCorso, 1990; Perché la Chiesa: Tomo 2: Il segno efficace del divino nella storia: Volume terzo del perCorso, 1992).
Nel 1986, esce Il senso religioso: Volume primo del perCorso (Jaca Book).
Nel febbraio 1988 il volume ottiene l’imprimatur ecclesiastico (in Curia Arch. Mediolani, die 15 febbraio 1988, Giovanni Saldarini pro Vic. Gen.); con l’occasione esce la seconda edizione dello scritto (Jaca Book), senza variazioni.
Nel 1994, esce Opere: 1966-1992, una miscellanea in due volumi che raccoglie tutti gli scritti di Giussani pubblicati da Jaca Book. Il primo volume ripropone Il PerCorso (pp. 1-618) e, in appendice, Il senso religioso nell’edizione 1977 (è infatti inclusa la “Nota di edizione” che non era presente nell’edizione 1966; pp. 619-682).
Nel 1995, Il senso religioso, esaurito nell’edizione Jaca Book del 1986, è ripubblicato da Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo.
Nel 1997 Rizzoli inizia la ripubblicazione del PerCorso in veste definitiva, che si concluderà nel 2003.
Nel primo volume, Il senso religioso, rispetto all’edizione precedente sono state aggiunte le note a piè di pagina e corretti i refusi.
Dal 2003 il primo volume del PerCorso è disponibile anche in edizione economica (BUR; nel 2010 pubblicato anche in formato pdf e ePub).
Nel 2007, per iniziativa editoriale di Rizzoli, l’opera è pubblicata nel volume L’itinerario della fede che ripropone integralmente il PerCorso (“Il senso religioso [1997]”, in Rizzoli, 2007, pp. 7-190).
Nel 2010, esce l’audiobook del volume Il senso religioso (Rizzoli, 2010), corredato di un fascicolo che, come è detto nella Nota introduttiva (pp. 5-6), ripropone due capitoli fondamentali dell’opera: “Capitolo quinto. Il senso religioso: sua natura” e “Capitolo decimo. Come si destano le domande ultime. Itinerario del senso religioso”.
Per iniziativa editoriale di RCS: Corriere della Sera, il 20 febbraio 2016 Il senso religioso esce in abbinamento al quotidiano nella collana “I manuali del Corriere della Sera”. Si tratta del primo di dieci volumi dell’Autore che saranno in edicola settimanalmente. Il volume è corredato di una Presentazione inedita redatta da Antonio Polito. Il testo di Giussani è una ristampa conforme all’originale dell’edizione Rizzoli, 2010.
Nel 2023, esce la nuova edizione BUR Rizzoli nella collana “Saggi”. Il testo di Giussani è invariato (corretti i refusi e aggiornate le note). La Prefazione di James Francis Stafford (redatta per l’edizione 1997 e presente nell’edizione 2010; pp. X-IX) è sostituita dal testo “Per l’uomo” (2023, pp. V-XI); si tratta dell’intervento del cardinale Jorge Mario Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires, pronunciato in occasione della presentazione pubblica dell’edizione spagnola per la diffusione in Sudamerica di Il senso religioso (El sentito religioso, Ediciones Encuentro; Editorial Sudamericana, 1998). L’incontro ebbe luogo a Buenos Aires il 16 ottobre 1998.
Il senso religioso (Rizzoli, 1997) è inoltre stato oggetto di riflessione in conversazioni fra l’Autore e alcuni membri dell’associazione Memores Domini (Quasi Tischreden) raccolte principalmente in L’autocoscienza del cosmo (BUR, 2000, T188-191, T196-197, T200), ma anche in altri volumi della medesima collana: «Tu» (o dell’amicizia) (BUR, 1997, T202), L’attrattiva Gesù (BUR, 1999, T195; nuova edizione BUR Rizzoli, 2025) e Dal temperamento un metodo (BUR, 2002, T198). [P. M.]