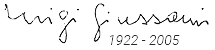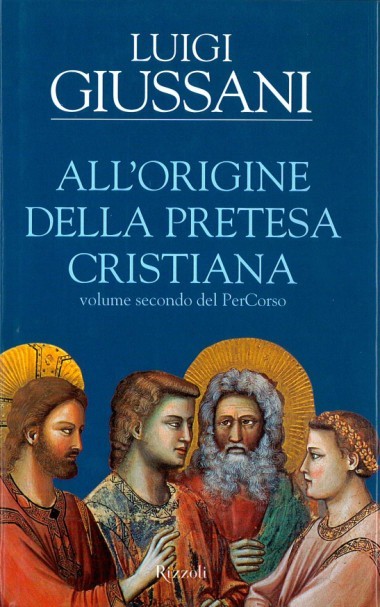Edizione aggiornata del volume All’origine della pretesa cristiana pubblicato da Rizzoli nel 2001. Il testo non ha subito modifiche sostanziali, sono stati corretti i refusi.
L’edizione 2011, analogamente a quella del 2001, si apre con la “Prefazione” dell’Autore (pp. V-VI). Nella parte iniziale è riproposta l’introduzione di All’origine della pretesa cristiana pubblicato negli Stati Uniti (“Preface” in At the Origin of the Christian Claim. McGill-Queen’s University Press, 1998, pp. XI-XII), mentre il seguito, in cui l’Autore approfondisce il significato e l’intento di questo testo, è stato redatto per l’edizione 2001.
Lo scritto All’origine della pretesa cristiana, secondo volume della trilogia il perCorso, fu pubblicato per la prima volta da Jaca Book nel 1988.
Già nelle primissime edizioni del volumetto Il senso religioso (GIAC, 1957, nei capitoli “L’iniziativa divina” e “Dio con noi”, pp. 15-21; Jaca Book, 1966, in “Parte terza. Rivelazione”, pp. 53-74; riedizione 1977, pp. 57-80) l’Autore aveva accennato alle tematiche che hanno poi trovato trattazione più ampia e autonoma nell’edizione Jaca Book.
Appartengono alla trilogia: Il senso religioso, Jaca Book 1986; Perchè la Chiesa: Tomo 1: La pretesa permane, Jaca Book, 1990, e Perchè la Chiesa: Tomo 2: Il segno efficace del divino nella storia, Jaca Book, 1992 (poi Rizzoli 1997-2003; nuova edizione 2010-2014).
Nel 1994 Jaca Book ripropone il testo nel primo dei due volumi che raccolgono gli scritti dell’Autore pubblicati sotto il suo marchio (Opere 1966-1992: Vol. 1: Il PerCorso, pp. 187-328).
Nel gennaio 2001 il volume, esaurito nell’edizione Jaca Book del 1988, è ripubblicato da Cooperativa Editoriale Nuovo Mondo.
Nel 2001, il secondo volume del PerCorso è pubblicato in veste definitiva. Rispetto all’edizione Jaca Book (1988), per l’edizione Rizzoli viene realizzato un importante lavoro di revisione al fine di favorire chiarezza e maggior comprensione del testo, ma anche, come afferma l’Autore, «per renderlo ancora più vicino al lettore di oggi», senza però modificare la struttura e l’impianto originari (“Prefazione”, p. VI).
Dal 2004 il secondo volume del PerCorso è disponibile anche in edizione economica (ristampe 2012 e 2013 nella collana BUR Saggi, rinnovata la veste grafica della copertina).
Nel 2007, per iniziativa editoriale di Rizzoli, l’opera è pubblicata nel volume L’itinerario della fede che ripropone integralmente Il Percorso (“All’origine della pretesa cristiana [2001]”, Rizzoli, 2007, pp. 191-310).
Nel 2010 Rizzoli pubblica l’audiobook del volume All’origine della pretesa cristiana, corredato di un fascicolo che, come è detto nella Nota introduttiva (pp. 5-6), ripropone l’introduzione e due capitoli fondamentali dell’opera: “Capitolo terzo. L’enigma come fatto nella traiettoria umana” e “Capitolo quarto. Come è sorto nella storia il problema”.
Per iniziativa editoriale di RCS: Corriere della Sera, il 27 febbraio 2016 All’origine della pretesa cristiana esce in abbinamento al quotidiano nella collana “I manuali del Corriere della Sera”. Si tratta del secondo di dieci volumi dell’Autore in edicola settimanalmente.
Ogni volume è introdotto da una nuova presentazione; per All’origine della pretesa cristiana lo scritto è tratto dall’omelia dell’allora cardinale Joseph Ratzinger ai funerali di don Luigi Giussani (pp. V-VIII; testo precedentemente pubblicato, con il titolo “Innamorato di Cristo. In un incontro la strada”, in “Don Luigi Giussani, 15 ottobre 1922 - 22 febbraio 2005”, Litterae Communionis-Tracce, 3 2005: pp. 20-21, e con il titolo Joseph Ratzinger: “Chi non dà Dio, dà troppo poco”, in Alberto Savorana Vita di don Giussani, Rizzoli, 2013, pp. 1187-1191).
Il testo di Giussani è una ristampa conforme all’originale dell’edizione Rizzoli, 2011, inclusa la “Prefazione” dell’Autore per l’edizione 2001 (2016, pp. IX-X; 2001 e 2011, p. V). [P. M.]