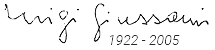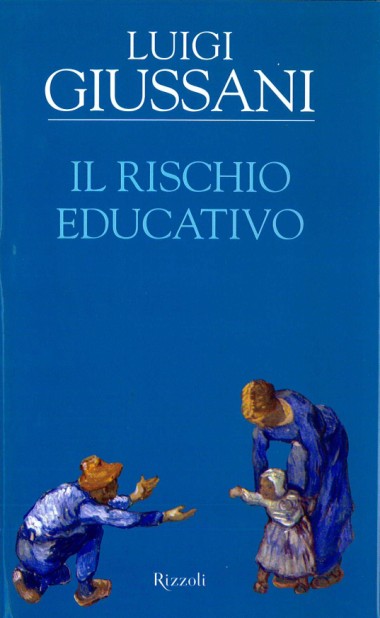Riedizione dell’opera Il rischio educativo (Rizzoli 2005).
Il testo di Giussani è invariato (corretti alcuni refusi nel testo e nelle note, in particolare si segnala la nota 39, 2005 e 2014, p. 92), è stata però aggiunta la Nota di edizione che riassume in breve le complesse vicende editoriali di questo scritto (p. 4).
L’opera Il rischio educativo è pubblicata per la prima volta da Jaca Book nel 1977 e successivamente rieditata nel 1988 (Jaca Book), nel 1994 (nel secondo dei due volumi che raccolgono gli scritti dell’Autore pubblicati da Jaca Book; Opere: 1966-1992. Vol. 2: Il rischio educativo, pp. 481-555) e nel 1995 (nel volume miscellaneo Il rischio educativo: Come creazione di personalità e di storia, SEI, 1995, pp. 3-56; quest’ultima pubblicazione contiene anche altri testi dell’Autore sul tema dell’educazione dei giovani).
Nel 2005 viene riproposto, per i tipi di Rizzoli, il nucleo originario dell’opera (che corrisponde alle parti “Dinamica e fattori dell’avvenimento educativo”, “Crisi e dialogo” e “Struttura dell’esperienza”, dell’edizione Jaca Book, 1977, pp. 11-95), con gli aggiornamenti voluti dall’Autore per le edizioni successive: il capitolo “Spunti introduttivi” aggiunti nell’edizione Jaca Book, 1988 (“Spunti introduttivi per la nuova edizione”, 1988, pp. 9-29; Rizzoli, 2014 e 2005, pp. 41-64); la Prefazione di Nikolaus Lobkowicz e l’“Introduzione” di Giussani redatte per l’edizione SEI, 1995 (2014 e 2005, pp. 5-38; SEI, 1995, pp. VII-XXV).
In occasione della ripubblicazione Rizzoli è stato operato un importante lavoro di revisione. Rispetto alle precedenti pubblicazioni sono stati espunti la Nota di edizione al volume Jaca Book 1977 (1977, pp. 9-12; 1988, pp. 33-35) e la parte “Conversazione con Luigi Giussani” (1977, pp. 97-110; 1988, pp. 101-111; SEI, 1995, pp. 157-162); i capitoli “Viterbo 1977” e “Insistenza”, presenti nella miscellanea edita da SEI nel 1995 (pp. 57-173). Inoltre, alla pagina 126 è stato corretto un errore presente in tutte le edizioni successive alla prima: il “Nota bene” che era stato erroneamente spostato in nota (Jaca Book, 1988, p. 95; SEI, 1995, p. 53) è stato riportato nel testo, dove si trovava nell’edizione Jaca Book del 1977 (p. 89).
La struttura del testo (suddivisione in capitoli e paragrafi) è quella dell’edizione SEI, 1995.
Il volume è stato pubblicato nel luglio 2005, successivamente alla morte dell’Autore avvenuta il 22 febbraio di quell’anno.
L’“Introduzione” (2014 e 2005, pp. 15-38) è la rivisitazione dell’intervento di Giussani alla conferenza “Un esempio di comunicazione religiosa”, tenutasi a Milano il 10 marzo 1995 in occasione del Salone del libro religioso. Prefazione e “Introduzione” sono state pubblicate in Litterae Communionis-Tracce (8 1995: inserto. Con successive traduzioni) con il titolo “Il rischio educativo. Come creazione di personalità e di storia”; brani dall’“Introduzione” sono stati pubblicati col titolo “Meglio educare che reprimere” in Il Giornale (24 settembre 1995, p. 16) e “Giussani, la sfida di educare” in La Stampa (6 ottobre 1995, p. 20).
Segue il testo “Il rischio educativo” nella stessa forma (suddivisione capitoli e paragrafi) in cui è stato proposto da SEI (“Parte prima. Il rischio educativo”, 1995, pp. 3-56), comprensivo quindi degli “Spunti introduttivi” (2005, pp. 41-64) stesi nel giugno 1986 per l’edizione del testo in lingua francese (Le risque éducatif, Nouvelle Cité, 1987, pp. 7-25) e inseriti nella riedizione italiana del 1988 (“Spunti introduttivi per la nuova edizione”, in Il Rischio educativo, Jaca Book, 1988, pp. 9-29). Il paragrafo “Tempi e contesti nell’attuazione di un metodo” (pp. 58-64), relativo a questa parte introduttiva, è stato pubblicato anche in Realtà e giovinezza. La sfida (SEI, 1995, pp. 158-161. Nuova edizione: Rizzoli, 2018, pp. 199-203) con il titolo “Ragione e compagnia”.
Il capitolo primo “Dinamica e fattori dell’avvenimento educativo” (pp. 65-110) è l’edizione riveduta e corretta dall’Autore del testo Adolescente, famiglia, scuola estratto dall’Enciclopedia dell’adolescenza (a cura di A. Valsecchi, Editrice Queriniana, 1965, pp. 263-286), ma riprende anche scritti del 1960.
L’origine del testo “Crisi e dialogo”, che costituisce il capitolo secondo, (pp. 111-125) è l’intervento di Giussani al IX congresso C.I.S.S. (Centro Italiano Stampa Studentesca) svoltosi a Loreto nel novembre 1963; il testo è stato pubblicato negli Atti del IX congresso C.I.S.S. (fascicolo monografico di Bollettino del Centro Italiano Stampa Studentesca, 1963) con il titolo “I giovani per la costruzione di una società nuova”. Nel 1964, dopo attenta revisione (aggiunta la “Conclusione” – Rizzoli, 2005, pp. 124-125 – e il titolo dei paragrafi, espunte alcune parti esemplificative), lo scritto è stato pubblicato con il titolo “Crisi e dialogo” nella rivista Okara (7 1964: pp. 3-5). Nel 1977 infine è confluito nella prima edizione del Rischio educativo (Jaca Book, 1977, pp. 67-86; espunto il penultimo periodo della parte intitolata “Situazione di oggi”, 1964, p. 5; 2005, pp. 123-124); il testo è presente in forma identica nelle edizioni Jaca Book 1988 e 1994 e nel volume miscellaneo SEI, 1995. Nella presente edizione il paragrafo “Dialogo” è intitolato “Apertura dialogica”, come nell’edizione 1977 (1977, p. 79; 2005, p. 120).
Il capitolo terzo “Struttura dell’esperienza” (pp. 126-132) è il testo del libretto L’esperienza (Gioventù Studentesca, 1963) scritto in risposta a una lettera dell’allora cardinale di Milano G.B. Montini, già presente nelle edizioni del 1977 e del 1988 e ripubblicato nel gennaio 1988 in Il Sabato con il titolo “L’esperienza del Mistero” (16, 1988, p. 18), nel 2002 in Litterae Communionis-Tracce con il titolo “L’esperienza” (4 2002: inserto. Con successive traduzioni) e nel 2009 in Litterae Communionis-Tracce con il titolo “La struttura dell’esperienza” (10 2009: inserto. Con successive traduzioni). Nel 1964, il paragrafo “L’esperienza cristiana” (punti a, b, c; 2005, pp. 130-132) è riportato anche in Appunti di metodo cristiano all’interno del paragrafo “L’incontro come esperienza” nel volume miscellaneo Il cammino al vero è un’esperienza (Rizzoli, 2006, pp. 155-157; prima edizione Appunti di metodo cristiano, Gioventù Studentesca, 1964, pp. 44-45).
Chiudono il volume gli indici (pp. 133-140). [P. M.]