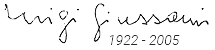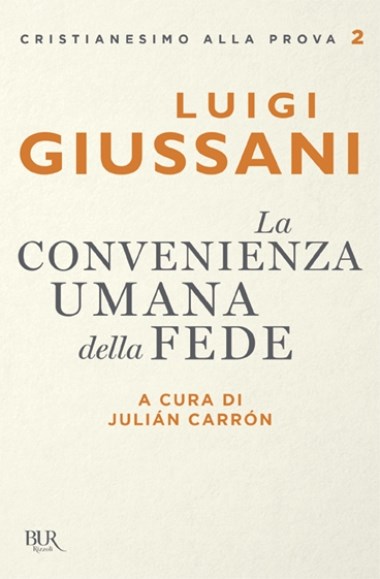Secondo volume della nuova serie “Cristianesimo alla prova” in cui sono riprodotte le lezioni, i dialoghi e le omelie dell’Autore durante gli Esercizi spirituali della Fraternità di Comunione e Liberazione.
Come si legge nell’ampia Nota editoriale, i testi sono stati redatti a partire da trascrizioni di registrazioni. Questo metodo si è reso necessario per il fatto che Giussani ha svolto lungo il corso della sua vita un’instancabile attività educativa, è accaduto quindi che gran parte del suo pensiero si sia comunicato attraverso la ricchezza e il ritmo di un discorso orale e sia giunto a noi mediante registrazioni audio e video conservate presso l’Archivio della Fraternità di Comunione e Liberazione a Milano.
I testi raccolti nel presente volume sono stati elaborati attenendosi ai criteri formulati a suo tempo dallo stesso Giussani: fedeltà ai discorsi nella forma in cui sono stati pronunciati; rispetto della natura dei discorsi (in relazione all’occasione in cui sono stati pronunciati); minime variazioni per favorire la resa scritta di un pensiero comunicato oralmente (cfr. p. 6).
Apre il volume la Prefazione di Julián Carrón dal titolo “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi” (pp. I-XVII).
Gli scritti proposti coprono un arco di tempo di tre anni: dal 1985 al 1987.
Ogni parte è introdotta da una breve nota storica a cura dei redattori, in corsivo nel testo.
La prima parte, “Ricominciare sempre: 1985” (pp. 7-113), riporta gli Esercizi della Fraternità che ebbero luogo a Rimini nel marzo 1985. Per far fronte all’aumentato numero di partecipanti, gli Esercizi si tennero in due turni, a distanza di una settimana l’uno dall’altro (15-17 e 22-24 marzo).
Come dichiarato (p. 11), fatta eccezione per il primo paragrafo, l’“Introduzione” propone quanto detto al secondo turno (pp. 11-20); si tratta di un testo inedito. Gli scritti restanti, invece, riguardano il primo turno.
Alcune parti del volume hanno avuto precedenti pubblicazioni:
- A breve distanza dagli Esercizi, fu editato un libretto pro manuscripto destinato alla circolazione interna al Movimento: Esercizi Spirituali della Fraternità di Comunione e Liberazione: Appunti dalle meditazioni (TIEMME, 1985. Testi non rivisti dall’Autore). In esso sono riportate le sintesi delle lezioni tenute dall’Autore.
L’“Introduzione” (1985, pp. 3-4) corrisponde a parte dell’“Omelia” durante la messa del venerdì sera (BUR, 2018, pp. 21-23).
La “Prima lezione” tenuta il sabato mattina (1985, pp. 5-14) corrisponde a parte del testo “Apparteniamo a un Altro” (2018, pp. 24-40).
La “Seconda lezione”, svoltasi il sabato pomeriggio (1985, pp. 15-28), corrisponde a parte di “Vivere l’ideale nell’istante” (2018, pp. 41-66).
La “Terza lezione” (1985, pp. 29-36) corrisponde a parte del capitolo “La vera convenienza” (2018, pp. 93-113).
Nella nuova pubblicazione BUR, 2018, sono stati corretti i refusi presenti nel testo del 1985.
- Nel 2002 parte della terza lezione è stata pubblicata anche nel volume L’opera del movimento: La Fraternità di Comunione e Liberazione: In occasione del ventesimo anniversario del riconoscimento pontificio con il titolo “Esercizi della Fraternità, primo turno, 15-17 marzo 1985” (San Paolo, 2002 e 2011, pp. 78-81. Con successive traduzioni).
Nello stesso volume è stata pubblicata in forma integrale anche l’“Assemblea” (2018, pp. 73-92) svoltasi sabato (“Esercizi della Fraternità: Primo turno, 16 marzo 1985”, San Paolo, 2002 e 2011, pp. 183-198. Con successive traduzioni).
Sono invece testi inediti il breve paragrafo “Avvisi” (2018, p. 23), l’“Omelia” del sabato e quella della domenica (BUR, 2018, pp. 67-72, pp. 110-113).
La seconda parte, “Il volto del Padre: 1986” (pp. 115-199), riporta gli Esercizi svoltisi a Rimini dal 4 al 6 aprile 1986. Anche in quell’anno gli Esercizi si tennero in due turni per soddisfare le numerose richieste di partecipazione. Giussani fu presente a partire dal sabato mattina perché la sera del 4 aprile era stato ricevuto in udienza privata da Giovanni Paolo II (cfr. p. 116). I testi qui pubblicati si riferiscono al primo turno.
- Una sintesi delle lezioni fu pubblicata quello stesso anno in un libretto pro manuscripto destinato alla circolazione interna al Movimento: Esercizi Spirituali della Fraternità di Comunione e Liberazione: Appunti dalle meditazioni (TIEMME, 1987. Testi non rivisti dall’Autore).
Il capitolo “Prima lezione: sabato 5 aprile mattino” (1986, pp. 5-16) propone in forma sintetica i testi pubblicati nel presente volume con i titoli “Introduzione alle Lodi” e “La coscienza del Padre” (BUR, 2018, pp. 117-145).
La “Seconda lezione” (1986, pp. 17-28) è la sintesi di quanto detto il sabato pomeriggio e corrisponde a parte del capitolo “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi” (2018, pp. 146-170).
La “Terza lezione” (1986, pp. 29- 42) è la sintesi di quanto detto la domenica mattina e corrisponde a parte del capitolo “Icaro, il rapporto con l’infinito” (2018, pp. 171-197).
- Alcuni brani, tratti dalle lezioni del sabato pomeriggio e della domenica mattina, nel 2002 sono stati pubblicati in L’opera del movimento: La Fraternità di Comunione e Liberazione (“Esercizi della Fraternità: 4 - 6 aprile 1986”, San Paolo, 2002 e 2011, pp. 82-87; BUR, 2018, pp. 162-163, pp. 166-167, pp. 177-180, pp. 182-183).
Sono inediti l’“Omelia” del sabato, quella della domenica (BUR, 2018, pp. 167-170, pp. 198-199) e il testo “Avviso” (2018, pp. 197-198).
La terza parte, “Sperimentare Cristo in un rapporto reale e storico: 1987” (pp. 203-267), riporta gli Esercizi svoltisi a Rimini dal 13 al 15 marzo 1987. Essi si tennero in un unico turno, formula che non sarebbe più stata abbandonata.
Una versione sintetica di quanto detto durante le lezioni fu pubblicata nel 1987 nel libretto pro manuscripto destinato alla circolazione interna al Movimento: Esercizi Spirituali della Fraternità: Appunti dalle meditazioni (TIEMME, 1986. Testi non rivisti dall’Autore).
Il capitolo “Introduzione: venerdì 13 marzo, sera” (1987, pp. 3-7) propone in forma sintetica i testi editi nel presente volume con i titoli “Introduzione” e “Omelia” (BUR, 2018, pp. 205-211).
La “Prima lezione: sabato 14 marzo, mattina” (pp. 9-20) corrisponde a parte del testo “Come Zaccheo” (2018, pp. 215-236).
La “Seconda lezione: sabato 14, pomeriggio” (pp. 21-30) è la sintesi di quanto detto il sabato pomeriggio e corrisponde a parte del capitolo “Nella carità la memoria diventa opera” (2018, pp. 237-252).
La “Terza lezione: domenica 15, mattina” (pp. 31-38) è la sintesi di quanto detto la domenica e corrisponde a parte del capitolo “La gloria di Cristo” (2018, pp. 254-267).
Sono, invece, testi inediti i paragrafi “Avvisi” (2018, p. 211) e “Introduzione alle Lodi” (2018, p. 214, p. 253).
Il volume si chiude con le “Fonti” (p. 269), gli “Indici” (pp. 271-292) e il “Sommario” (pp. 293-295). [P. M.]