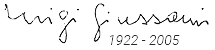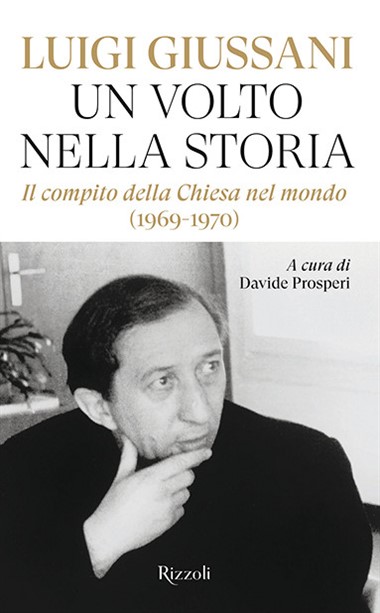Il volume raccoglie undici lezioni di Luigi Giussani tenute alla prima edizione della «Scuola di comunione» del Centro Péguy, nel periodo che va da marzo 1969 a giugno 1970. Le lezioni, con cadenza mensile, erano rivolte ad adulti che, dopo la crisi del ’68, intendevano continuare e rinnovare l’esperienza cristiana iniziata nella scuola.
Il testo esprime la concezione del cristianesimo di don Giussani e la sua rilevanza per il costituirsi di una personalità umana matura, capace di giudizio e di azione nuovi.
I capitoli del libro si legano tra loro in linea progressiva – un capitolo si richiama al precedente e lo sviluppa – e in chiave tematica. Così, il capitolo secondo è la ripresa e l’approfondimento del primo; il terzo è una conclusione della prima parte del discorso e lo spunto per proseguire; il tema del capitolo quarto è considerato il punto di partenza di tutto il discorso cristiano, l’argomento del quinto è la chiave metodologica e quello del sesto è il suo determinante etico e culturale. A partire dal capitolo settimo e fino alla fine sono poi considerate le caratteristiche del cristiano nel suo modo di vivere il rapporto con la vita e il mondo in base alla fede cristiana.
Il primo capitolo (“Chiesa e mondo”), dedicato alla ricerca di una definizione del nesso tra l’oggettivizzarsi della comunione cristiana (Chiesa) e l’ambito della vita umana (mondo), consta di due principi e di due indicazioni di metodo. Il primo principio riguarda lo scopo del cristianesimo (cioè di Cristo e della Chiesa), che viene con chiarezza individuato nell’educazione religiosa dell’umanità. Il secondo concerne il compito del cristiano, il quale collabora alla risoluzione concreta dei problemi personali e sociali secondo due coordinate: la loro collocazione storico-temporale (storia, tempo, evoluzione) e la libertà umana (che include anche genialità, generosità, intelligenza e volontà). Questi due principi si attuano attraverso due leggi metodologiche corrispondenti: la comunione cristiana, la Chiesa, come metodo per comunicare e partecipare al «fatto cristiano» e l’incarnazione, come incidenza, attraverso la propria umanità, sui problemi umani. Nel nota-bene finale si sottolinea l’inseparabilità dei quattro fattori e la tensione che essi imprimono nella vita.
Questi contenuti sono ripresi e approfonditi, nel secondo capitolo (“La missione”), nella meditazione della parola “missione”, considerata centrale nella concezione della personalità cristiana. Dopo aver ripercorso, nei Vangeli, la figura di Cristo come colui che è stato “mandato” e dopo aver indicato nella partecipazione alla Sua missione il significato della vita cristiana, si sottolinea la sinonimia tra missione e povertà – e quindi distacco da sé e dai propri beni -, per poi passare ai tre fattori della missione. Il primo riguarda il soggetto della missione, che è il costituirsi – per grazia, dono, partecipazione storica al corpo di Cristo - della personalità cristiana, come il prima di ogni azione e come spazio di comunione. Il secondo fattore è il contenuto della missione: l’annuncio del disegno buono del Padre, nella paradossalità della croce e nella certezza della risurrezione, affinché Dio sia tutto in tutti. Il terzo è la condizione della missione: il coinvolgimento pieno con la condizione umana e con le urgenze, i bisogni, i problemi che essa presenta. Il capitolo termina con un richiamo all’urgenza di avere un volto nel mondo, nei tentativi tesi a migliorarlo e dinanzi alle inevitabili ostilità.
Lo sviluppo e la conclusione dei primi due capitoli si trova nel terzo (“Veritatem facientes in caritate”), nel quale sono esaminati i capisaldi teorici e pratici della concezione cristiana. Il primo: il fondamento della speranza cristiana, come speranza d’uomo, è il mistero di Cristo, reso presente nella Chiesa. Di qui la necessità, secondo caposaldo, per contribuire al cambiamento e al miglioramento del mondo, di costruire la Chiesa, nella condizione umana e nelle situazioni in cui gli uomini si trovano, a partire da quelle più prossime. Terzo: la comunicazione, nel mondo, del cambiamento che avviene nella comunità cristiana, evitando qualsiasi dualismo, giacché il mondo è dentro la Chiesa e la Chiesa è l’orizzonte del cambiamento del mondo. In tal senso, quarto, l’appartenenza alla comunità cristiana non è definita arbitrariamente, ma essa è aperta a tutti coloro che riconoscono e accettano l’annuncio cristiano. Infine, quinto cardine, il bisogno di una comunità cristiana è il cambiamento sensibile portato da Cristo, nei rapporti e nelle vicende della vita, ossia di “miracoli” che realizzino la verità nella carità.
Il quarto capitolo (“Il Cristo globale, nostra speranza) contiene la tesi principale del libro, Cristo nostra speranza, presentata come la prima frase di una pagina che deve essere poi scritta nei capitoli successivi. Anzitutto si nota la radicalità di tale affermazione, normalmente accettata, a motivo della sua globalità: per il cristiano, la speranza fondata in Cristo ha valore fin da questa vita, implicando la totalità della personalità umana e della vita. Ciò muta la concezione e la percezione del futuro, che non deve essere separato dal presente, ma ne è la realizzazione, ossia è considerato il compimento di una salvezza già presente. La continuità tra presente e futuro è la “grossa novità” che fa da premessa a tre spunti principali sulla speranza, così indicati: a) la speranza investe tutta la storia: Cristo come speranza globale riguarda la vita in tutti i suoi aspetti, nel presente e nel futuro; b) questa speranza muta il modo di vedere e l’analisi della vita, personale e sociale; c) la speranza cristiana agisce sulla persona, poiché attraverso essa passa la risoluzione dei problemi del mondo. L’importanza del fenomeno della persona è rimarcato dal valore della preghiera e dell’amicizia, accennati a fine capitolo.
La costruzione del discorso sulla speranza ha nel tempo, di cui tratta il quinto capitolo (“Cristo e il tempo”), l’elemento metodologico fondamentale. Dopo una ripresa del nesso strettissimo tra speranza cristiana e salvezza dell’uomo, sono svolti tre punti principali, articolati in paragrafi interni.
Nel primo, il tempo umano è implicato nella salvezza di Cristo, in quanto dinamica che sollecita la libertà umana, intesa come tensione alla piena realizzazione dell’essere umano – dunque volta al futuro -, ma anche come condizionamento lungo il cammino, per le scelte che si possono compiere.
Il secondo punto tratta del “disegno di Dio” in raccordo con l’esistenza del singolo essere umano e della “volontà di Dio” come avvenimento storico, che porta la vita dentro il “disegno” – l’alleanza tra Dio e popolo ebraico, nell’Antico Testamento, la creatura nuova che nasce col Battesimo nel cristianesimo -.
Alle conseguenze antropologiche è dedicato il terzo punto: anzitutto, la fede, presentata come ciò che qualifica la figura dell’uomo nuovo; in secondo luogo, la pazienza, vista come l’atteggiamento che la fede provoca nell’uomo nel suo rapporto con le cose e con se stesso. Della pazienza sono segnalati i due fattori fondamentali: la coscienza dello scopo buono di tutte le cose e l’energia con cui le cose possono essere possedute.
Dopo il capitolo quinto inizia la disamina del volto del cristiano nel mondo e, quindi, del valore e della natura della costruzione della Chiesa.
Primo elemento di tale fisionomia è il giudizio nuovo generato dalla fede, la mentalità nuova che scaturisce dalla conversione cristiana. Il tema è posto nel capitolo sesto (“Il giudizio finale sul mondo”) e viene ripreso nel capitolo decimo, a proposito della condivisione dell’umano bisogno.
Come premessa della capacità di giudicare la realtà è richiamato il Dio dell’Antico Testamento, che si manifesta come Signore della storia attraverso la conoscenza e il giudizio. Di tale sguardo sulle cose, profeticamente affermato, Cristo rappresenta il compimento, come giustizia – superamento della legge antica – e giudizio – senso dell’esistenza umana e della storia -. In polemica col mondo, come i Vangeli attestano, Cristo introduce un criterio nuovo per giudicare la realtà, è pietra di paragone per definire il valore dell’azione umana nella storia e trova nella comunità cristiana, la Chiesa, il luogo ove dimostrare la sua vittoria. Per il cristiano, perciò, la fede è anzitutto conoscenza del criterio sintetico per giudicare la realtà e la comunione cristiana è genesi di giudizio e, quindi, di azione nuovi.
Un breve riassunto del percorso compiuto apre il capitolo settimo (“La povertà, volto del cristiano nella storia”), dedicato alla prima caratteristica del cristiano nel mondo, la povertà di spirito. Nella dialettica della vocazione cristiana tra “già e non ancora”, la povertà è la radice di un possesso intelligente e vero delle cose e dei beni, ben descritto da San Paolo nella II lettera ai Corinti. Il povero vive nella pace ed è sorretto dall’audacia, puro e sincero nelle intenzioni, capace di carità vera e di gioia, sempre vigile e attento, anche se pellegrino e straniero sulla terra.
La povertà è così la prima categoria della costruzione della Chiesa. A essa segue, come seconda categoria, l’impegno alla liberazione dal male, argomento del capitolo ottavo (“La liberazione dal male”).
Introdotta da un’analisi del problema del male, in rapporto alla libertà umana, e del disegno di salvezza divino, la liberazione dal male trova la sua radice nel gesto gratuito della libertà di Dio verso l’uomo, nel paradosso del giusto sofferente, nella definitiva vittoria attraverso la morte e la risurrezione di Cristo. All’uomo, questa morte e questa risurrezione sono comunicate dallo Spirito, come dono – kerygma e sacramenti - che mette in lui la radice della liberazione e un cuore nuovo.
In tutto ciò risiede l’ideale del cristiano: nel possesso vero e permanente delle cose. Questo tema “fragile e precario”, trattato nel capitolo nove (“Il possesso della realtà in Cristo risorto”), è considerato in stretto rapporto con la ricerca della pienezza del proprio essere e con la maturità della coscienza e del sentimento del cristiano. Il possesso delle cose e di se stessi era stato profeticamente annunciato nell’Antico Testamento, nell’ideale dei cieli nuovi, di un’epoca di fecondità e ricchezza, di un rinnovamento del cuore che avrebbe portato a una terra nuova, in cui avrebbe regnato la pace. Con Cristo, questo possesso nuovo è stato reso possibile, e nel riconoscimento di ciò risiede il valore profondo della “verginità”, come esperienza di novità umana, capace di vivere in pace e in comunione e di darne testimonianza, come avvenne per i primi martiri del cristianesimo.
Il decimo capitolo riprende il tema del giudizio (“Giudizio e teoria nuovi”) e l’iniziale tematica del corso: il rapporto tra la vita di comunione e la realtà mondana, o, più precisamente, il nesso tra la fede cristiana e il bisogno umano. Le riflessioni svolte sul problema della condivisione, della giustizia sociale, dell’efficienza delle azioni per migliorare le condizioni degli uomini, hanno particolare importanza sia sul versante storico – il delinearsi di una posizione originale dopo il ’68 – sia su quello della concezione dell’impegno del cristiano nel mondo. Della condivisione del bisogno e dell’efficienza dell’azione sociale sono, in particolare, sottolineate le condizioni dell’essere veramente dentro le situazioni concrete e dell’essere veri nell’agire.
Conclude il percorso delle meditazioni il capitolo undicesimo (“Il lavoro e la missione come conversione”), in cui, ribadendo il tema trattato – la “salvezza del mondo”, la speranza riposta in Cristo per la salvezza propria, degli altri, del mondo -, si ripercorrono le parole del cammino fatto – salvezza, speranza, pazienza, povertà di spirito, comunione cristiana, edificazione della Chiesa -, si segnalano due errori da evitare – concezione secolarizzata del comportamento e concezione moralistico-cultuale del cristianesimo -, e si sollecita all’intensità e totalità dell’impegno missionario, nel segno di un’indomita passione per Cristo, per la Chiesa e per la salvezza del mondo.